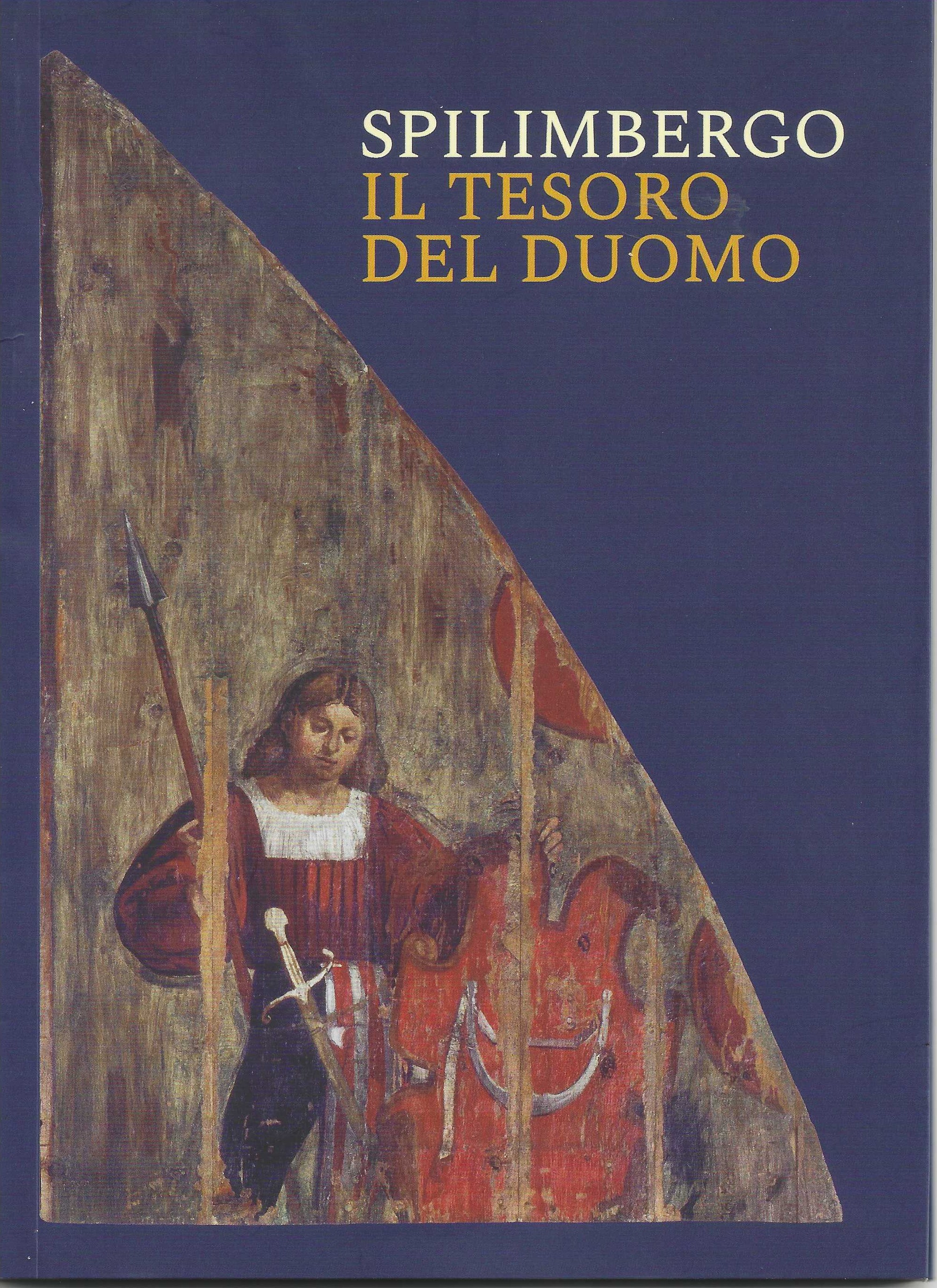Da sinistra Enrico De Nicola, presidente della Camera e futuro presidente provvisorio della Repubblica; il re e Mussolini (1923).
Da sinistra Enrico De Nicola, presidente della Camera e futuro presidente provvisorio della Repubblica; il re e Mussolini (1923).
 Articolo di
Milo Julini
Articolo di
Milo Julini
.jpg) Ministri che vanno, ministri che vengono, e altri che restano
Ministri che vanno, ministri che vengono, e altri che restano
“Rivoluzione fascista” come tanti hanno detto? Il “28 ottobre 1922” fu subito regime, come molti hanno scritto riecheggiando Emilio Gentile? Dopo le “impressioni” e le chiacchiere, stiamo ai “fatti”.
Quando sul mezzogiorno del 29 ottobre 1922 l’aiutante di campo del Re, gen. Arturo Cittadini, lo invitò a Roma per assumere l’incarico di formare il governo, il trentanovenne Benito Mussolini non aveva mai sentito parlare del “Manuale Cencelli”. Il mio amico “Max” lo invento mezzo secolo dopo. Però lo applicò, perché anche lui, “duce delle camicie nere” seguì la regola non scritta della “politica” nella democrazia parlamentare da Camillo Cavour a Giovani Giolitti: la spartizione. Ogni “partito” o gruppo parlamentare della maggioranza aveva diritto a propri rappresentanti nell’esecutivo. Presieduto da Luigi Facta, il governo uscente era una coalizione di “liberali” di varia denominazione e osservanza (Paolino Taddei, Carlo Schanzer, Giulio Alessio, De Capitani d’Arzago, Teofilo Rossi...), democratici (Giovanni Amendola), demosociali (Colonna di Cesarò) ed esponenti del cattolico partito popolare (Giambattista Bertone, Stefano Cavazzoni, Antonino Anile).
Salutata a casa la moglie Rachele Guidi e corso alla Stazione Centrale di Milano con Margherita Sarfatti, sua Ninfa Egeria, nel viaggio in vagone letto da Milano verso Roma Mussolini abborracciò una lista di ministri comprendente fascisti, nazionalisti, democratici sociali, popolari, liberali (tra i quali Luigi Einaudi) e almeno un socialista “moderato”, Gino Baldesi o Bruno Buozzi. Esclusi rimanevano solo social-comunisti e repubblicani, che un giorno sì e l’altro pure chiedevano la fine della monarchia e quindi erano fuori gioco.
I tormenti di Luigi Facta (Pinerolo, 1861-1930)
Il tardo pomeriggio del 27 ottobre 1922, dopo lunghe tergiversazioni, come si legge nel Verbale firmato da Facta e da Marcello Soleri, “il Consiglio dei Ministri prende in esame la situazione politica e delibera di rassegnare a Sua Maestà le sue dimissioni”. Per il deputato di Pinerolo era la seconda volta in pochi mesi. Lo aveva già fatto il 19 luglio quando, “in seguito al voto politico della Camera”, il governo rassegnò le dimissioni e si aprì una normalmente tormentosa crisi parlamentare, risolta dopo settimane con la formazione del secondo governo presieduto da Facta, un deputato di scuola giolittiana, più volte ministro, esperto di finanza pubblica. Nel suo corso, riunito per affari urgenti il 28 luglio, il Consiglio dei Ministri mise a verbale che, “essendo dimissionario”, non poteva “decidere registrazioni con riserva (provvedimenti) che costituiscono atti politici”. Figurarsi misure eccezionali di ordine pubblico. Come tutti i governi dimissionari, doveva occuparsi degli “affari correnti”.
A differenza di quanto accaduto a luglio, il 27 ottobre Facta aprì una crisi extraparlamentare. Da inizio ottobre Vittorio Emanuele III gli aveva ripetutamente chiesto di convocare le Camere che non si riunivano da quando il 9 agosto gli avevano concesso una risicatissima fiducia, in eloquente assenza dei maggiorenti di area liberale (Giovanni Giolitti, Vittorio Emanuele Orlando, Antonio Salandra...). Sordo ai moniti del re e convinto di essere un “politico” abile e navigato, anziché parlamentarizzare la crisi Facta giocò in proprio, trattando con Benito Mussolini per dar vita a un governo comprendente qualche ministro del PNF, come ormai proponevano anche Giolitti, Orlando, il presidente della Camera Enrico De Nicola e tutti i partiti costituzionali. Nelle “Memorie” postume Soleri scrisse che in quei giorni aveva anche lui tutti i requisiti per trovare la soluzione giusta con Mussolini di cui si considerava buon amico. Non solo, nella certezza di poter gabbare il duce del fascismo e i suoi accoliti trascinando la crisi in lungo, Facta propose a Gabriele d’Annunzio di presiedere il IV novembre 1922 un’adunata di Grandi Invalidi per chiamare all’unità nazionale e consolidare un suo terzo ministero, rafforzato dall’ingresso di qualche fascista, magari persino con Mussolini in un ministero secondario.
Il “metodo Facta”, tuttavia, si rilevò fallimentare.
Che cosa accadde veramente il 28 ottobre 1922? Cent’anni dopo, sulla certezza storiografica continua ancora a prevalere la “narrazione”: i “fatti” rimangono sotto la polvere di molti “si dice” e di fantasie spacciate per verità. La coincidenza di quel centenario con le odierne elezioni politiche non ha certo giovato a una revisione pacata degli eventi. Ha spinto, anzi, ad alzare i toni sulla soluzione della lunga crisi di un secolo fa, già esacerbati da Antonio Scurati in “M. Il figlio del secolo” (Bompiani, 2018), che però ha l’attenuante di dichiararsi “Romanzo”. Le polemiche sull’incombenza di un nuovo “regime” hanno spinto a ripetere luoghi comuni sull’avvento del governo Mussolini, insediato il 31 ottobre 1922, descritto quale espressione della “Rivoluzione fascista”, formula retorica affacciata dal “duce” nel discorso del 3 gennaio1925 e poi divenuta canonica con i cinque volumi di Giorgio Alberto Chiurco sulla “Storia della Rivoluzione fascista” (Vallecchi, 1929), con la Mostra del 1932 sul Decennale della “marcia su Roma” e con i tre volumi della “Storia della Rivoluzione fascista” di Roberto Farinacci, il “ras” di Cremona che, come soleva, copiò anche il titolo della sua “opera”.
Il 26 ottobre 1922 Facta aveva rassicurato il sovrano, il quale, al rientro dal viaggio di Stato in Belgio, attendeva notizie a San Rossore (Pisa). Dette per cessato il pericolo di “marcia” delle squadre fasciste verso Roma. Ma tornò a evocarlo poco dopo, con un lunghissimo telegramma giunto al re alle 0.10 del 27 ottobre. Vittorio Emanuele gli rispose che si sarebbe messo subito in viaggio per Roma. Vi giunse verso le 20 del 27. E si trovò dinnanzi al vuoto: la crisi extraparlamentare.
Con le dimissioni deliberate la sera del 27 ottobre, infatti, fu proprio Facta ad aprire la crisi, a Camere chiuse (la loro convocazione era prevista il 9 novembre), mentre gli esponenti più responsabili e prestigiosi dell’area liberale e “cattolica” erano lontani dalla Capitale. Il governo scaricò sulle spalle del re la ricerca della soluzione politica e su quelle del comandante della divisione militare di Roma, gen. Emanuele Pugliese, la tenuta dell’ordine pubblico nella Città Eterna: presupposto necessario, quest’ultimo, per la soluzione della crisi, poiché, come Vittorio Emanuele III ruvidamente disse a Facta nel breve colloquio alla Stazione Termini, il re doveva decidere in piena libertà. Come le altre maggiori città del Paese Roma era tranquilla. Altrove si susseguivano assalti di squadre fasciste a sedi di poteri pubblici, nodi ferroviari, uffici telegrafici e telefonici. Nulla di incontrollabile perché le direttive impartite dal ministro dell’Interno, Paolino Taddei, erano chiare: respingere ogni illegalità facendo uso delle armi, se necessario, e arrestando i capi della sedizione e, all’occorrenza, trasmettendo la cura dell’ordine ai comandi militari, come avvenne a Firenze e altrove. L’esercito fece la sua parte senz’alcuna esitazione.
Dall’ordine allo stato d’assedio: il salto nel vuoto
La mattina presto del 28 ottobre il Consiglio dei ministri deliberò “ad unanimità di proporre al Re la proclamazione dello stato d’assedio, e autorizz(ò) tutti i provvedimenti per fronteggiare la situazione politica e finanziaria, conferendo ai ministri competenti le relative facoltà, con ogni più ampio mandato di fiducia e delega perché la crisi si svolga in piena libertà di decisioni”. Dunque, come ovvio, il governo non deliberò lo stato d’assedio (non era nei suoi poteri) ma di proporlo al re. Sennonché, prima che Vittorio Emanuele decidesse, il proclama fu diramato alle prefetture e a tutti i destinatari di rito. Venne anche stampato e affisso sulle cantonate. Era sabato. Borsa e banche erano chiuse. Se anche vi fu, il panico degli ambienti finanziari paventato da Soleri non ebbe conseguenze.
Nel verbale del Consiglio dei ministri non si trova notizia dell’Appello del governo al Paese, che pure ebbe due diverse redazioni e a sua volta venne pubblicato nei giornali e affisso, né degli eventi successivi. Il governo non si radunò più. Svaporò. Vittima di se stesso.
Alle 9 del 28 ottobre Vittorio Emanuele III rifiutò di firmare il decreto istitutivo dello stato d’assedio e allo sconcertato Facta che gli domandò che cosa fare con i manifesti già affissi gli rispose di “fare come il segretario di Monasterolo” (un piccolo comune del Cuneese) che incautamente aveva pubblicato un avviso di mobilitazione militare: il sindaco gli ordinò di andare a toglierli con le sue mani.
Assistito dall’aiutante di campo gen. Cittadini nella lunga veglia tra il 27 e il 28 ottobre Vittorio Emanuele III si trovò pressoché solo a sbrogliare l’aggrovigliata matassa della crisi extraparlamentare in assenza di statisti di assoluta fiducia sua e del Paese e mentre incombeva il pericolo vero: non l’avanzata di squadristi (erano tutti bloccati a decine di chilometri da Roma grazie alle drastiche misure dettate dal gen. Pugliese con l’interruzione delle linee ferroviarie a Civitavecchia, Orte, Tivoli, Sezze...) ma lo scontro armato tra fascisti e militari. Il suo dubbio sulla lealtà dell’esercito è una diceria di terza mano. Nasce da una dichiarazione del gen. Roberto Bencivenga rilasciata nell’agosto 1945 a Efrem Ferraris, capo gabinetto di Facta: il generale (e poi maresciallo d’Italia) Pecori Giraldi gli aveva confidato che il re aveva consultato lui stesso e Diaz sulla condotta dell’Esercito. Il duca della Vittoria avrebbe risposto “l’Esercito farà il suo dovere, però sarebbe bene non metterlo alla prova!”. Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre Diaz era a Firenze. È improbabile che il re lo abbia consultato telefonicamente e che quelle siano state le sue parole. A Bencivenga il maresciallo Pecori Giraldi non disse quale sia stata la sua personale risposta. Sarebbe interessante conoscerla. L’unica certezza è che Diaz fu nominato ministro della Guerra nel governo Mussolini, mentre il Grande Ammiraglio Paolo Thaon di Revel divenne ministro della Marina. I vertici delle Forze Armate erano con la Corona, come tutti gli ufficiali e la generalità dei graduati. Altra certezza è che alle 7.30 del 28 ottobre il re ricevette in udienza il catanese Ernesto Civelli (intendente generale della marcia su Roma a fianco del foggiano Gaetano Postiglione) che gli assicurò la fedeltà degli “squadristi” alla monarchia, come ricordato da Chiurco e da quanti (come Antonio Di Pierro) lo copiarono senza citarlo.
Secondo un’altra leggenda destituita di fondamento Vittorio Emanuele III temette che i fascisti gli contrapponessero Emanuele Filiberto di Savoia (non Amedeo, suo primogenito, a differenza di quanto si legge in “L’insurrezione fascista” di Mimmo Franzinelli e in “Gli uomini della marcia su Roma” di Mauro Canali e Clemente Volpini). L’Italia uscita vittoriosa dalla Grande Guerra con il Re Soldato perennemente al fronte e per anni a ricomporre le beghe tra governi, partiti e il Comandante Supremo Luigi Cadorna, non era un principato balcanico. I primi a respingere un’ipotesi di quel genere sarebbero stati i quadrumviri Emilio De Bono e Cesare Maria De Vecchi, ricevuti dalla Regina Margherita pochi giorni prima a Bordighera.
Solo la mattina del 28 ottobre, su incalzante sollecitazione del Quirinale, Facta telegrafò a Giolitti, Filippo Meda (cattolico moderato) e Mussolini che il re li desiderava a Roma per consultazioni sulla crisi. Giolitti, il più atteso, rispose solo nel pomeriggio. Tutto andava a rilento mentre il tempo incalzava. Sul mezzogiorno del 29, rifiutato l’ingresso in un governo coalizione presieduto da Salandra, Mussolini venne invitato a Roma per ricevere l’incarico formale. Dopo la forzata sosta del treno a Civitavecchia, nella lista dei ministri egli sostituì Einaudi con Alberto De Stefani e Baldesi con Stefano Cavazzoni, del partito popolare. Ma non voleva la rottura completa con i socialisti riformisti. Infatti ancora il 16 novembre dichiarò alla Camera il proposito di averne il sostegno.
Nel “Diario”, curato da Marco Pignotti (Ed. dell’Orso), Francesco Cocco Ortu, deputato dal 1876, decano della Camera e unico liberale contrario al governo Mussolini, ricorda che il “duce” comunicò a Federzoni la nomina a ministro delle Colonie (forse il capofila dei nazionalisti sperava di avere gli Esteri) e troncò rapidamente la conversazione. Di fatto il “duce” formò il governo in meno di 24 ore. Il 31 avvenne il rituale passaggio di consegne tra i ministri uscenti e quelli subentranti, compresi Facta e Taddei, in un clima di assoluta normalità.
Il nuovo governo contò tre fascisti: il massone Aldo Oviglio alla Giustizia, Giovanni Giuriati alle Terre Liberate e De Stefani alle Finanze. Gli altri dicasteri andarono a popolari (Tangorra e Cavazzoni), liberali (Carnazza) e democratici sociali (Colonna di Cesarò). All’Istruzione fu nominato Giovanni Gentile, tra i più influenti filosofi e organizzatori culturali del Novecento. Gli si deve l’”Enciclopedia Italiana”. Fu vilmente assassinato da un comunista a Firenze il 15 aprile 1944, nell’ambito della trama ricostruita da Luciano Mecacci (Premio Acqui Storia). De Capitani rimase all’Agricoltura e il giolittiano conte Teofilo Rossi di Montelera fu confermato all’Industria e Commercio. Caso unico nel “ventennio”, il 23 novembre 1922 il conte Rossi presiedette il Consiglio dei ministri in assenza di Mussolini in viaggio a Londra, ove ottenne plausi e consensi da chi sin dal 1917 aveva retto le danze finanziandone l’ascesa, come narrano José Cereghino e Giovanni Fasanella nell’imminente “Nero di Londra” (Chiarelettere).
Scorrendo quei nomi e verificando le realizzazioni di quell’esecutivo sino alle elezioni del 6 aprile 1924 risulta fuorviante liquidare i primi sedici mesi di governo come fosse capeggiato da “una banda di delinquenti, guidati da un uomo spietato e cattivo” (lo scrive Aldo Cazzullo in “Il capobanda”, ed. Mondadori). Né può tacersi che quel governo il 17 novembre 1922 ebbe l’approvazione della Camera a larghissima maggioranza, ricalcata da quella, anche più ampia, al Senato, il 27 seguente.
Due ultime constatazioni “di fatto”. Se l’Italia non fosse stata una monarchia rappresentativa ereditaria e se il capo dello Stato fosse stato elettivo, non v’è dubbio che alle prime elezioni successive all’ottobre 1922 Mussolini sarebbe stato eletto a furor di popolo, avrebbe ottenuto pieni poteri assoluti su tutto e su tutti e nessuno avrebbe potuto revocarlo e sostituirlo, come invece fece Vittorio Emanuele III il 25 luglio 1943. In secondo luogo, come già era accaduto a fine ottobre del 1922, i “politici” del Comitato di liberazione nazionale dall’estate 1943 al giugno 1944 rifiutarono di collaborare con il governo del Re, che rimase solo a fronteggiare la tracotanza dei vincitori, decisi a declassare l’Italia dal rango di aspirante grande potenza qual era stata dall’unificazione del 1861: una retrocessione dalla quale non si è più ripresa.
FINE
CENT’ANNI FA L’AVVENTO DEL GOVERNO MUSSOLINI
UN CONVEGNO DI STUDI A VICOFORTE (1° ottobre 2022)
Il 30 ottobre 1922, al termine di una convulsa crisi politica extraparlamentare, Vittorio Emanuele III incaricò Benito Mussolini di formare il governo, che si insediò in 24 ore. L’Esecutivo comprese tutti i partiti costituzionali: nazionalisti, liberali, demosociali, popolari, il giolittiano Rossi di Montelera e due militari di fiducia del Re, Armando Diaz e Thaon di Revel, e tre fascisti, compreso Mussolini. Nessuno pensò che il nuovo governo fosse l’inizio di un “regime di partito unico” né di una dittatura personale.
Quali furono le radici remote e prossime di quella crisi e della sua soluzione? Vittorio Emanuele III decise per paura che i fascisti volessero sostituirlo con suo cugino Emanuele Filiberto duca d’Aosta? O perché l’Esercito non si sarebbe opposto alle “squadre” capitanate dal “quadrumviri” Balbo, Bianchi, De Bono e De Vecchi in marcia verso Roma? A distanza di un secolo tanti interrogativi attendono risposte documentate e convincenti. Perciò se ne parla nel Convegno di studi di sabato 1° ottobre a Vicoforte (Casa Regina Montis Regalis, attigua al Santuario ove dal dicembre 2017 riposano le Salme di Vittorio Emanuele III e della Regina Elena). Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 si susseguono studiosi di chiara fama sulla scorta di documenti inediti. Con Alessandro Mella e Gianni Rabbia, intervengono Giuseppe Catenacci (Associazione ex Allievi della Nunziatella), Tito Lucrezio Rizzo (La Sapienza, Roma, “Metamorfosi di un regime”), Raffaella Canovi (“D’Annunzio iniziato?”), Dario Fertilio (“I giornali di opinione”), Federico Lucarini (“Salandra e Giolitti”), Luca Manenti (“La Massoneria italiana nel 1922”), gen. Antonio Zerrillo (“Forze Armate e polizia nella crisi”); GianPaolo Ferraioli (“La politica estera tra continuità e discontinuità”), Massimo Nardini (“La crisi italiana vista dalla Francia”), col. Carlo Cadorna (“La strategia dalla Vittoria al governo Mussolini”), Aldo G. Ricci (“Il suicidio delle sinistre”), Gianpaolo Romanato (“I cattolici tra due crisi”). Giorgio Sangiorgi proietta e commenta filmati d’epoca. Aldo A. Mola spiega perché il vero “golpista” fu Luigi Facta, che rassegnò al re le dimissioni del governo e pretese l’adozione dello stato d’assedio di cui non v’era alcun bisogno perché a favore dell’incarico a Mussolini si schierarono partiti, forze economiche, la chiesa cattolica e le massonerie.
Il convegno è promosso da Istituti, Centri studi ed Enti.
Cultura

Reg. Stampa num.22
del Tribunale Ordinario di Torino
11 Marzo 2011
Copyright © 2010
ASSOCIAZIONE CULTURALE "BORGO DORA - I RESIDENTI DI TORINO"
All Rights reserved.
IN
CIMA


.jpg)