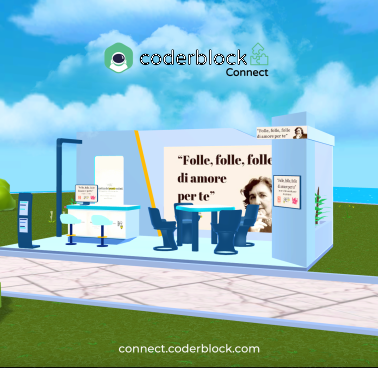Inauguriamo i ritratti di giovani poeti attraverso le recensioni di poeti un po’ meno giovani, quindi spesso più approfonditi nella frequentazione letteraria. Ecco quindi Paolo Pera con la disamina quasi chirurgica dell’intellettuale Mario Marchisio, un uomo con alle spalle notevoli studi della letteratura non solo italiana e ricerche teologiche, oltre a una laurea in giurisprudenza.
Paolo Pera, Pena di me stesso (Ensemble 2022)
Un’esplicita nota “crepuscolare”, innestata sull’altrettanto esplicito autocompiacimento per la propria solitudine, caratterizzava l’esordio di Paolo Pera ne La falce della decima musa (2020).
Tutto ciò ha lasciato in seguito spazio a qualcosa di nuovo, tant’è vero che il poeta può evocare oggi nella Premessa il confronto (e lo scontro) psicologico, ideologico, esistenziale e metafisico, con la realtà circostante e col problematico fondamento che la trascende: Dio.
Nulla da eccepire a una simile scelta – o destino – tragica e ironica a un tempo.
Ma poiché abbiamo qui a che fare con una raccolta di versi, cercheremo di enucleare i cardini intorno ai quali ruota la sua dimensione propriamente letteraria, precisando tuttavia come il nuovo corso della poesia del nostro autore sia già iniziato con Pietà per l’esistente, che si prolunga e si completa in questa Pena di me stesso (ciò traspare fra l’altro fin dal titolo della citata Premessa: Pietà per l’esistente e/o Pena di me stesso).
Da un punto di vista formale, si osservi anzitutto la tendenziale isometria dei versi, verificabile a partire dal secondo libro di Pera, Pierino Porcospino (2021).
In Pena di me stesso, tuttavia, l’intento satirico-parodistico sfuma a favore di un atteggiamento che tenta a più riprese, con piglio quasi stoico, di contrapporsi ai fantasmi della mente e ai loro sgradevoli risvolti nella concretezza della vita quotidiana.
È dunque una pena tutta particolare quella che l’io poetico esperimenta nei confronti di se stesso.
Solo affrontando l’estrema umiliazione, e identificandosi in un corpo che abbia cessato d’esistere, l’io acquista uno sguardo obiettivo sul mondo:
«Oggi ripenso a ciò che ero / Prima di disfarmi davvero».
Al contempo, però, al di là di ogni sforzo d’identificazione,
«La scalata alla conoscenza / Poggia sul mio sterno / Ogni gradino percorso».
Se duro è il destino umano, ancor più duro sarà quello di chi ardisca scrivere, poiché costui verrà tormentato da domande paradossali, fra cui ad esempio la seguente:
«Tutto questo vuole dire / Che mi tocca respirare?».
Una memoria elefantiaca quanto implacabile sospinge allora l’aspirante stoico ad augurarsi una completa demenza.
La sesta, imprescindibile sezione della raccolta, intitolata Momenti di debolezza, sviluppa il discorso poetico della seconda (Il tempo che non ritroveremo), da cui sono stati citati fin qui alcuni versi.
Ebbene, leggendo Momenti di debolezza comprendiamo come l’autobiografismo esasperato abbia consentito al poeta di attingere un’insperata consapevolezza che si affianca, illuminandolo, a quel vagheggiato dominio di sé cui accennavo più sopra.
Ed ecco che il taglio patetico, altrove ancora presente, viene messo a tacere e direi perfino sublimato in composizioni che suonano come esemplari “testamenti”. Penso ad esempio a Insensatezza, dall’incipit sentenzioso e lapidario («Nulla ha senso infine. / Siamo il movente che ci guida / Nelle fauci del leone»), o alla successiva quartina priva di titolo che spicca per la notevole efficacia e che sarebbe riprovevole non trascrivere per intero: «Agisco senza posa, / Agisco e invento / Il valore da conferire / A quanto fa soffrire».
Pena di me stesso non andrebbe comunque letto come un’opera a sé, poiché – lo accennavo più sopra e qui lo ribadisco – completa idealmente un dittico la cui prima anta è costituita dal libro che la precede. Non si tratta però soltanto, nella raccolta odierna, di un ovvio mutamento di oggetto: dal disprezzo intriso di commiserazione verso il mondo (l’esistente) alla diagnosi e prognosi severa verso se stessi.
Sussiste infatti anche da questo punto di vista una nota nuova, che a mio avviso riveste un’importanza decisiva nell’economia del dittico e che va ricercata fra le pieghe del solipsismo del nostro poeta, deciso ormai a lasciarsi alle spalle il modello berkleyano ancora all’opera in Pietà per l’esistente per approdare a una sua curiosa variante, secondo la quale non esiste l’io se gli altri non ne certificano l’esistenza.
Come? Tramite un contatto con esso, e in particolare tramite il suo riconoscimento.
La novità essenziale di Pena di me stesso consiste dunque in un solipsismo in cui il ruolo del Dio di Berkeley è svolto dagli altri, da coloro che ci circondano.
Qualcuno ricorderà forse un dramma di Sartre in cui il filosofo francese metteva in bocca a un suo personaggio questa affermazione: «L’inferno sono gli altri».
Paolo Pera, con la raccolta di versi che abbiamo appena finito di leggere estende la portata tragica di quella frase.
Gli altri sono infatti anche il paradiso: sono l’unico fondamento del nostro esistere. Di più: sono il nostro creatore e il nostro distruttore.
Quanto allo stilita del componimento iniziale, la sua «altissima colonna» è ormai deserta.
A libro chiuso, aleggia nell’aria l’auspicio che in qualche luogo della mente egli possa conseguire l’inoppugnabile prova di non esser stato un mero frutto dell’immaginazione.

 Articolo di
Chicca Morone
Articolo di
Chicca Morone