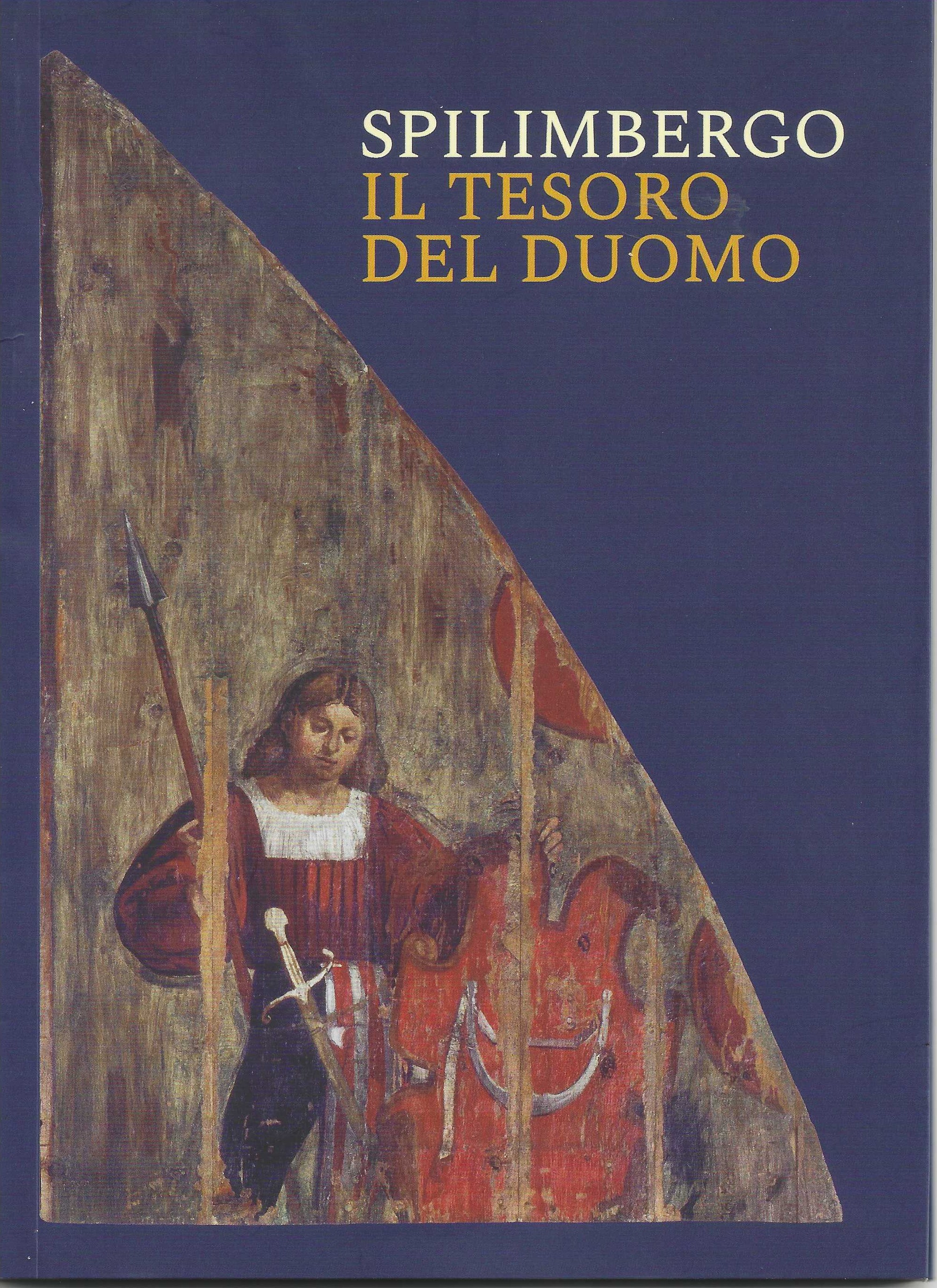Giacomo Acerbo
Giacomo Acerbo
 Articolo di
Milo Julini
Articolo di
Milo Julini
 Un consesso di patrioti
Un consesso di patrioti
Il 23 marzo 1939 Vittorio Emanuele III inaugurò la XXX legislatura pronunciando il rituale Discorso della Corona, concordato, come da prassi, con il capo del governo, Benito Mussolini. La Camera di 400 deputati, eletta in blocco nel 1934 sulla base della legge 17 maggio 1928, era stata sostituita con quella “dei Fasci e delle Corporazioni”, parte di nomina, parte con elezione di secondo grado. I suoi componenti presero nome di “consiglieri”.
Alle acclamazioni il re rispose movendo la destra, come soleva fare. Secondo il numero straordinario della “Gazzetta Ufficiale” rispose “salutando romanamente”. Non venne chiesta una rettifica. Ben altro premeva. Malgrado la conferenza a Monaco di Baviera (28 settembre 1938) avesse scongiurato la guerra, l’Europa era inquieta. “Per mettere in valore le risorse del suo Impero – disse il re-imperatore – l’Italia, pur non cullandosi nella illusione della pace perpetua, desidera che la pace duri il più a lungo possibile”. Al termine del suo discorso i parlamentari intonarono “gli inni della rivoluzione fascista” e, dopo l’uscita dei Reali, tributarono “un’ardente manifestazione di devozione e di affetto al Duce”. Se la Camera era totalmente asservita a Mussolini, il Senato ne era in gran parte succubo o latitante.
Dopo un lustro di totale stasi, tra il 25 marzo e il 20 ottobre 1939 con tredici “infornate” vennero nominati 211 senatori, compresi quattro dignitari dell’Albania (la cui corona in aprile era stata assunta da Vittorio Emanuele III) per la categoria 20^, riservata a quanti avevano “con meriti e servizi eminenti illustrato la patria”. Quali?
I nuovi patres erano “fascisti”? Alcuni sì, anche se neppure Mussolini spiegò mai quale fosse precisamente la “dottrina” del fascismo. Divise e rituali a parte, il fascismo nacque e rimase politeista. Perciò dilagò. I nuovi senatori erano nazionalisti, ex liberali, democratici, riformisti o semplicemente “uomini d’ordine” (industriali, agrari, banchieri, scienziati, artisti...) che si riconoscevano nel governo ed erano orgogliosi di entrare a far parte della Camera Alta dopo aver servito a lungo lo Stato. Erano diplomatici, militari, magistrati, accademici di chiara fama, che non avevano bisogno di alcuna tessera di partito. Tra i generali possono essere ricordati Angelo Tua, Valentino Bobbio, che intervenne presso Mussolini a favore del nipote Norberto, Melchiade Gabba, Raffaele Montuori, Guglielmo Nasi, l’ammiraglio Inigo Campioni, fucilato con Luigi Mascherpa su sentenza di un tribunale della Repubblica sociale italiana, e Ambrogio Clerici. Prevalenti furono i nuovi patres per la categoria 21^: Alberto Beneduce, socialista, antifascista, già oratore del Grande Oriente d’Italia, presidente dell’Istituto per la ricostruzione italiana, e Luigi Burgo (di confessione evangelica, a conferma che il Senato non accoglieva solo cattolici). Foltissima fu la rappresentanza dell’aristocrazia d’ogni regione: Giuseppe Asinari Rossillon di Bernezzo, Salvatore Denti Amari di Pirajno, Febo Borromeo d’Adda, Ugolino della Gherardesca, Luigi Arborio Mella di Sant’Elia, Alfredo Dentice di Frasso... Fascisti? Le loro biografie dicono tutt’altro. Erano patrioti, come Federico Baistrocchi, Arrigo Serpieri, Luigi Aldrovandi Marescotti, Ambrogio Bollati, Giorgio Emo Capodilista, Carlo Torlonia. Alcuni nuovi patres, come il massonofago Paolo Orano, vantavano molte genuflessioni al regime e al suo duce, ma costituivano una minoranza. Di diritto, di pensiero e di fatto in maggior parte erano anzitutto e soprattutto “uomini del Re”, come lo erano stati i presidenti della Camera Alta Tommaso Tittoni e Luigi Federzoni, che nelle lettere a Mussolini lo appellavano “Eccellenza” (in quanto capo del governo) anziché “duce”, che sapeva di partito. Nella seduta che il 16 maggio 1936 approvò l’istituzione dell’Impero mentre al banco della presidenza, a cominciare da Mussolini, con le mani alla cintola, erano tutti in camicia nera, i senatori l’avevano bianca, a eccezione di Giovanni Gentile e pochi altri.
Scialuppa nella tempesta
Fiutato il vento, Mussolini mirò a imbrigliare il Senato. La sua presidenza fu conferita al bergamasco conte Giacomo Suardo (1883-1947), senatore per la categoria 21^, una sola legislatura da deputato e modesti incarichi governativi, prono al duce. La legge 19 gennaio 1939, n. 129 ridusse drasticamente le materie che richiedevano sedute plenarie delle Camere. Le altre furono competenza di Commissioni (nuova denominazione degli “Uffici”) con funzioni deliberanti (una mortificazione delle Assemblee, fatta propria dalla Repubblica). Le votazioni in aula divennero esclusivamente pubbliche e in molti casi si ridussero a chiassose “acclamazioni”. Con la dichiarazione di guerra (10 giugno 1940) i lavori delle Commissioni non ebbero più alcuna pubblicità. I senatori di nuova nomina giurarono dinnanzi all’Ufficio di Presidenza anziché in Aula. L’obiettivo del duce era chiaro: soffocare l’opposizione dei patres monarchici.
Va peraltro aggiunto che Mussolini non svigorì solo le Camere ma anche il Gran consiglio del fascismo, “organo della rivoluzione”. Esso non fu più convocato dal 7 dicembre 1939 al 24 luglio 1943, quando approvò l’ordine del giorno Grandi-Federzoni-Bottai-De Marsico che “pregò il Re” di esercitare i poteri statutari sottraendo a Mussolini il comando delle forze armate.
Il 20 ottobre 1940, vigilia del rovinoso attacco dell’Italia alla Grecia, Suardo inviò a Mussolini una servile informativa sull’allineamento del Senato al regime, ricordata da Aldo Pezzana in Gli uomini del Re. Il Senato durante e dopo il fascismo (Foggia, Bastogi, 2001): 454 dei 497 patres erano iscritti al partito. Gli altri erano suddivisi in “irriducibili” (i liberali Abbiate, Albertini, Bergamini, Canevari, Casati, Conci, Croce Serristori, Tomasi della Torretta), gli ebrei (Castellani, Diena, Levi, Loria, Mayer, Morpurgo, Segrè Sartorio), i “non frequentanti” per motivi di salute o vaghi pretesti (Badaloni, De Nicola, Di Rovasenda, Einaudi, Frassati, Mosca, Vigliani...), i “non iscritti ma non contrari”, soprattutto militari, come Dallolio, Pecori Giraldi, e diplomatici, quali Guglielmo Imperiali, Giuseppe Salvago Raggi e l’antico socialista Adolfo Zerboglio, deputato di Alessandria. Su tutti spiccava il maresciallo Enrico Caviglia, collare della SS. Annunziata (quindi “cugino del Re”), da Suardo bollato “una carogna” per il suo fiero antifascismo.
Sic stantibus rebus dal 20 ottobre 1939 non avvennero altri ingressi nella Camera Alta.
Tre anni e mezzo dopo, il 6 febbraio 1943, il re nominò 34 senatori, tra i quali Carlo Costamagna, Guido Donegani, Giacinto Motta ed Edoardo Rotigliano. Il regime scricchiolava, non solo per le sconfitte militari ma anche, e soprattutto, per il peggioramento delle condizioni di vita quotidiana, il razionamento dei beni di prima necessità, la divaricazione tra la retorica mussoliniana e la realtà. Tra l’8 e il 12 novembre 1942 gli anglo-americani erano sbarcati in Marocco e Algeria. In dicembre l’Armata Rossa aveva travolto quella italiana sul fronte del Don. Nella conferenza di Casablanca (14-26 gennaio1943) gli Alleati decisero l’assalto all’Italia per imporle la resa senza condizione. Il 2 febbraio l’armata tedesca comandata da von Paulus aveva perso la battaglia di Stalingrado. Tra il 6 e il 15 febbraio Mussolini sostituì i titolari dei ministeri principali: Esteri, Giustizia, Educazione nazionale, Finanze, Lavori pubblici, Corporazioni, Scambi e valute. Furono rimossi Galeazzo Ciano, Dino Grandi, Giuseppe Bottai, Host Venturi mentre Luigi Federzoni da tempo era ai margini della “politica”. Il duce stesso pose le premesse della “cospirazione” dei gerarchi del 24-25 luglio, illusi di conservare un fascismo senza Mussolini. I regimi monocratici crollano con la caduta del loro “capo”. Ma l’Italia non era una diarchia. Era ancora monarchia.
Vittorio Emanuele III aveva un progetto del tutto diverso: sostituire Mussolini e sciogliere il partito nazionale fascista quale premessa per la richiesta di armistizio. Lo sbarco anglo-americano in Sicilia (10 luglio) impresse l’accelerazione. I senatori non rimasero inerti a cospetto della crisi. Il 22 luglio 63 patres presenti in Roma “data la gravità della situazione” chiesero a Suardo la convocazione del Senato in seduta plenaria. Molti erano di recente nomina, altri indossavano il laticlavio da anni. La richiesta non fece alcun cenno al fascismo. Tre giorni dopo venne superata dalla revoca di Mussolini da capo del governo e dalle dimissioni di Suardo da presidente del Senato, sostituito con Paolo Thaon di Revel. Sentito il re, il 3 agosto Badoglio, che non aveva competenza in materia ma era ansioso di ergersi a campione della “svolta”, decise di non pubblicare la richiesta dei 63 senatori. Il giorno prima aveva decretato lo scioglimento della Camera dei fasci e delle corporazioni, del Gran Consiglio del fascismo e di altre organizzazioni del regime e impose le stellette alla Milizia volontaria di sicurezza nazionale, sciolta il 6 dicembre. Dato l’assetto bicamerale del Parlamento, l’azzeramento della Camera paralizzò il Senato, concentrò i poteri nelle mani del governo e sovraespose la Corona, privata dello scudo statutario del legislativo. Vittorio Emanuele III rifiutò di firmare un decreto propostogli da Badoglio, corrivo ad assumere il potere legislativo, e lamentò all’aiutante di campo Paolo Puntoni: “Cominciamo bene. Per prima cosa vogliono farmi firmare un decreto anticostituzionale”. In balia della tempesta, il Senato non svolse alcun ruolo nelle settimane conclusesi con la resa incondizionata sottoscritta dal generale Giuseppe Castellano a Cassibile (3 settembre) e con il trasferimento da Roma a Brindisi del capo del governo, della Famiglia Reale e dei capi di stato maggiore (9-11 settembre).
Abolizione ed epurazione del Senato: RSI e Alta corte “partigiana”
Nella prima seduta il governo dello Stato fascista repubblicano d’Italia, poi Repubblica sociale italiana (Rocca delle Caminate, 27 settembre 1943), decretò lo scioglimento e l’abolizione del “Senato di nomina regia” e ne privò i componenti delle prerogative e immunità che li rendevano giudicabili solo dall’Assemblea, costituita in Alta Corte di giustizia. Perciò ebbe mano libera per far processare e condannare a morte i senatori firmatari dell’ordine del giorno del 25 luglio: Federzoni, De Vecchi e De Bono, che, prigioniero, venne fucilato con Galeazzo Ciano e altri gerarchi a Verona il 6 gennaio 1944. Aveva 78 anni. Altrettanto avvenne per Inigo Campioni, pluridecorato, governatore di Rodi, fucilato il 24 maggio 1944 a Parma con il contrammiraglio Luigi Mascherpa, iniziato massone nella Gran Loggia d’Italia, al termine del vergognoso “processo degli ammiragli”.
Sul regio Senato calò dunque subito la scure della RSI. Ma pochi mesi dopo scese anche quella dei governi del regno. Dopo la defascistizzazione, avviata dall’indomani della revoca di Mussolini, con l’avvento del governo del Comitato di liberazione nazionale presieduto da Ivanoe Bonomi (18 giugno 1944) giunse l’ora dell’epurazione. In premessa va ricordato che il Comitato centrale di liberazione nazionale sin dall’esordio (agosto 1943) e poi dalla sua auto-proclamazione (ottobre) aveva rifiutato di collaborare con il governo del re. Nella primavera del 1944 l’offensiva contro la monarchia divenne incalzante. Su pressione degli statunitensi il 12 aprile Vittorio Emanuele III comunicò che avrebbe conferito tutti i poteri al principe ereditario Umberto di Piemonte in Roma, quando la Capitale fosse stata liberata. Il 26 maggio 1944 fu emanato il regio decreto legge per la punizione degli “atti rilevanti” compiuti per “il mantenimento del regime fascista e dell’ingresso dell’Italia in guerra”. Il “legislatore”, cioè il governo, sommò una filza di equivoci. Quando nacque il regime? Nell’ottobre 1922? Allora sul banco degli imputati andavano chiamati quanti avevano votato a favore del governo Mussolini. Non solo “liberali” (Croce, Orlando, De Nicola, Einaudi, oltre a Casati, ministro nel suo governo...) ma anche Alcide De Gasperi e una lunga serie di “democratici”. Datò dal 3 gennaio 1925? Ma allora era nulla la nomina a senatori di quanti avevano avuto il laticlavio dopo quella data, a cominciare appunto da De Nicola e da molti capifila dell’antifascismo (con esclusione di socialcomunisti e azionisti, s’intende). E quale sarebbe stata la sorte di Badoglio, duca di Addis Abeba?
Il 7 agosto 1944, il sedicente conte Carlo Sforza, alto commissario per l’epurazione, propose al presidente dell’Alta corte di giustizia, istituita per giudicare i conniventi del regime, la decadenza di 307 senatori. Per lui il Senato era “un club vitalizio di vecchi funzionari, vecchi generali, vecchi e non vecchi industriali, vecchi terrieri”. Per la prima volta venne introdotta in Italia una legge retroattiva. Giuristi niente affatto fascisti, come Guido Astuti, Massimo Severo Giannini e Arturo Carlo Jemolo, deplorarono la grave violazione del principio fondamentale di diritto “nullum crimen sine lege”. La “connivenza” con l’avvento del regime era un’“invenzione” per colpire avversari politici, declassati a nemici del popolo. Precorrendo la sentenza, Sforza, chiese subito al presidente del Senato, Tomasi della Torretta, di interdire ai senatori sotto accusa l’accesso a Palazzo Madama. Essi vennero privati dei diritti civili. L’obiettivo era dichiaratamente politico: togliere al re il sostegno della classe dirigente di sua fiducia, intimorire e piegare ogni opposizione all’avvento della repubblica di cui era fautore. Va ricordato che nel “famigerato ventennio” nessuno ne aveva messo in discussione il rango e il ruolo di senatore, benché fosse all’estero, assente alle sedute, e non mancasse occasione di vituperare le istituzioni dello Stato italiano.
L’elenco degli “epurati” è lunghissimo. Ottanta di essi (a cominciare da Pietro d’Acquarone, ministro della Real Casa, artefice con il re della revoca di Mussolini) ricorsero ma si videro respingere l’istanza. Trentatré morirono in attesa del responso. Nei loro confronti fu ordinato il “non luogo a procedere per decesso”. La loro “lista” si apre con Giovanni Agnelli, defenestrato dalla Fiat, e comprende l’israelita Elia Morpurgo, deputato dal 1895 al 1919, morto mentre veniva deportato nel Reich e nondimeno “epurato”. Diciannove ottennero la revoca dell’ordinanza (Vittorio Cini, Luigi Burgo, Umberto Locatelli, Aldo Rossini...). Per diversi motivi in ventisette (De Vecchi, Federzoni...) non ricorsero affatto. Per la “nuova Italia” avevano già dato, rischiando la fucilazione da parte dei mussoliniani a oltranza.
Resurrezione, sì, ma tardiva
Il calvario del regio Senato e dei suoi componenti continuò. Sino al referendum istituzionale del 2-3 giugno1946 la Camera Alta rimase in una sorta di limbo. Con l’avvento della repubblica aleggiò l’interrogativo: che cosa fare? De Gasperi si affrettò a dichiarare lo scioglimento del Senato ma la Corte dei conti non registrò il decreto perché esorbitante dalle sue competenze. Quindi i patres sopravvissero persino oltre la fine della monarchia. Non solo. Con varie sentenze la Corte di Cassazione via via accolse i ricorsi contro la dichiarazione della loro decadenza, propugnati da uno specchiato giurista quale Giuliano Vassalli, antifascista a ventiquattro carati.
Con la legge costituzionale 29 ottobre 1947, n. 3 (entrata in vigore il 7 novembre, giorno della sua pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”) il capo provvisorio dello Stato De Nicola promulgò quanto deciso dal governo De Gasperi: “soppressione del Senato e determinazione della posizione giuridica dei suoi componenti”. Uccise l’uomo morto? Sì e no. Molti senatori si videro reintegrati dalla Cassazione. Non solo. L’Assemblea costituente deliberò che nella prima legislatura repubblicana il Senato avrebbe compreso 107 “senatori di diritto” per meriti antifascisti di varia natura e 237 eletti. Molti di essi erano stati senatori del regno.
Il loro peso politico non fu affatto marginale per la storia d’Italia. Nelle elezioni del 18-19 aprile 1948 la Democrazia cristiana ottenne la maggioranza dei seggi alla Camera dei deputati, ma non altrettanto in Senato, ove conquistò 133 seggi sui 237 in palio (meno del 50%) e ne ebbe ancor meno per l’ingresso dei “senatori di diritto”, tra i quali anche ex parlamentari cattolici. Si fermò a 151 patres su 344. Perciò, constatato di non avere la maggioranza per governare da sola, si rassegnò a condividere il “potere” con i partiti “laici”: repubblicani, socialdemocratici e liberali, parecchi dei quali monarchici. Essa stessa, d’altronde, contava nelle sue file monarchici notori, garanti della continuità dello Stato e convinti che le disposizioni “transitorie e finali” della Costituzione fossero tali di nome e di fatto e che pertanto prima o poi sarebbe stato cancellato il divieto di rientro e di soggiorno in Italia della Regina Elena, di Umberto II e della sua famiglia.
Non avvenne. Perciò, per tenere viva la Tradizione, il Re, mai abdicatario, costituì la Consulta dei senatori del regno, aperta agli “uomini dello Stato”, anche “in servizio” in nome e a garanzia della continuità della storia d’Italia.
Aldo A. Mola

Giacomo Acerbo, barone dell’Aterno, sottosegretario alla presidenza del Consiglio all’avvento del governo Mussolini, già iniziato massone nella loggia “Nazionale” della Gran Loggia d’Italia ministro dell’Agricoltura dal 1929 al 1935 e delle Finanze dal 6 marzo al 25 luglio 1943, componente della Consulta dei senatori del Regno dal 10 luglio 1961. Nel 1962 il presidente Antonio Segni gli conferì la Medaglia d’Oro di benemerito della Scuola.
Cultura
IN
CIMA



.jpg)