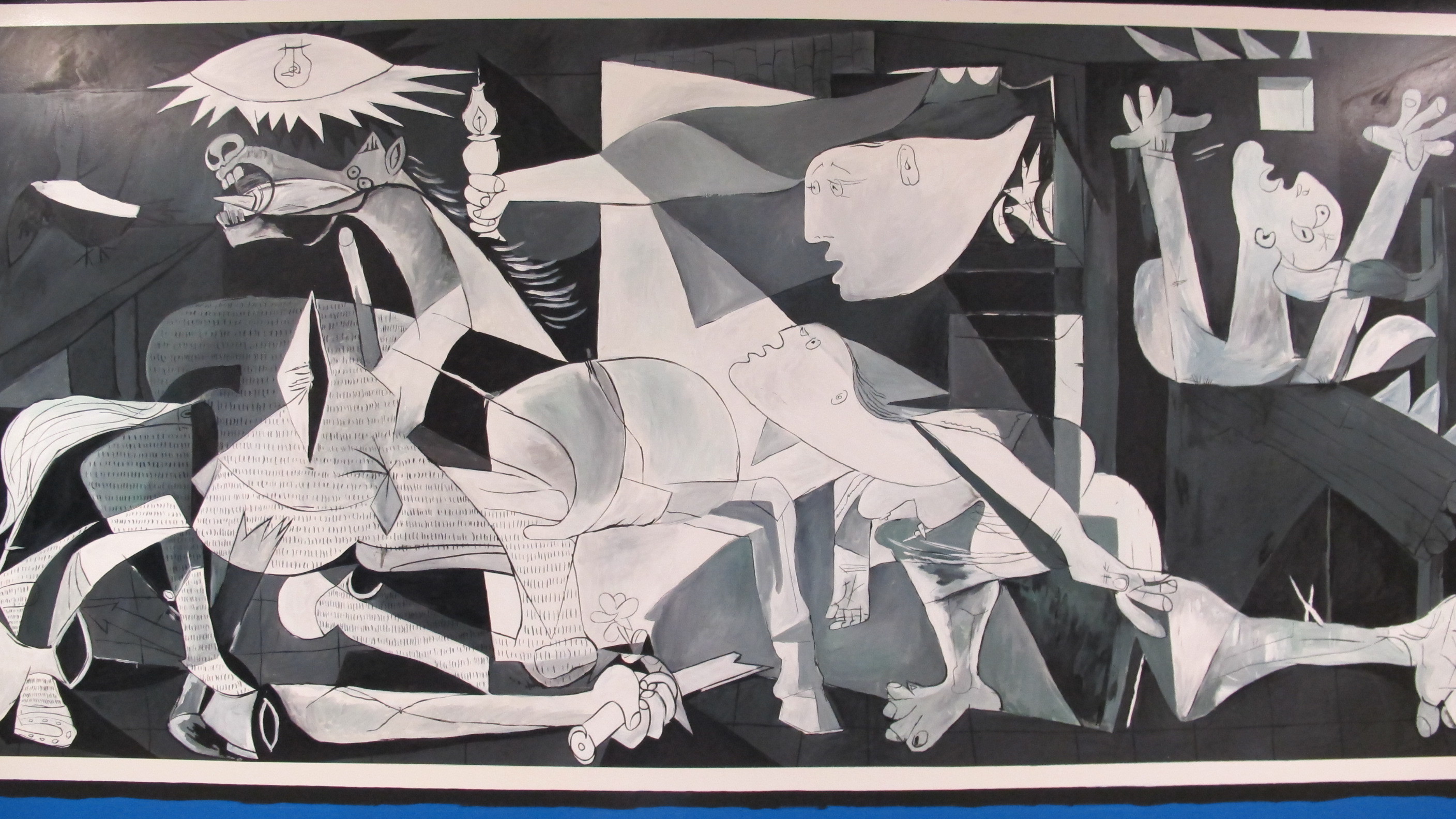Riflessioni economico-politiche sul Belpaese dal dopoguerra a oggi
Pur nel suo complesso apprezzando l’articolo “Dalla fast alla slow-economy?”, un mio acuto lettore ha obiettato che l’inciso finale secondo cui la politica, se avesse voluto, avrebbe potuto (adottando adeguate strategie), almeno in parte migliorare il contesto economico italiano al pari di quanto avvenne negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, rappresentasse una previsione poco realistica, poiché le circostanze storiche (specie quelle internazionali) sono oggi significativamente mutate.
L’eccezione è fondata e merita accoglimento, pur con alcune precisazioni che si diranno.
Indubbiamente vero è che, a seguito della suddivisione dell’Europa tra sfera d’influenza russa e quella americana avvenuta con la Conferenza di Jalta (1945), il contesto geopolitico venutosi a formare abbia agevolato una robusta crescita del nostro paese.
Infatti, l’Italia non solo aveva il più forte partito comunista d’occidente (in larga misura dipendenze dalle decisioni di Mosca), ma a oriente confinava con la Jugoslavia del generale Tito (1892-1980) che, pur con i distinguo che caratterizzarono la sua posizione rispetto all’URSS, rappresentava comunque un diretto “pericolo comunista”.
A partire poi dalla metà degli anni Sessanta e quindi per l’intero decennio successivo, l’Italia fu attraversata da energici movimenti di protesta (quasi sempre ideologicamente orientati a sinistra), da scioperi, occupazioni, lotte sindacali, che si mescolavano a prospettive rivoluzionarie o, all’opposto, a nostalgie fasciste e che, in politica, prendevano (tra gli altri) i nomi di Potere operaio, Democrazia proletaria, Lotta Comunista, Ordine Nuovo, piuttosto che Movimento sociale italiano.
Appare dunque comprensibile come né il governo italiano né gli USA potessero (e volessero) permettersi che il malcontento oltrepassasse la soglia della tollerabilità, andando a ingrossare gli estremi, soprattutto laddove questi si mostravano disposti a ricorrere alla violenza, al pari di quanto avvenne negli “anni di piombo”.
Ne seguì – per il vero, non sin da subito, ossia non fino a quando nella Democrazia Cristiana primeggiarono esponenti quali Giuseppe Pella (1902-1981), la cui fortuna politica tuttavia declinò a partire dai primi anni Sessanta – una strategia economica alquanto conciliante nei confronti delle classi sociali meno abbienti che, nel corso di una quindicina d’anni, si trasformarono (grazie all’impegno e all’intraprendenza di un’intera generazione) nei ceti medi degli anni Settanta e Ottanta, permettendo ai loro figli di mantenere un buon tenore di vita pure quando, dal 1992 in avanti, l’Italia iniziò a declinare economicamente.
Inoltre corretto è che il sistema produttivo del periodo post-bellico risultasse significativamente differente rispetto all’attuale e che lo stesso consentì il diffondersi di un generalizzato benessere. Intanto, c’era un’Italia da ricostruire: case, ponti, strade, fabbriche, linee elettriche e telefoniche. Tutto richiedeva manodopera e creava ricchezza. In secondo luogo, l’accresciuto livello tecnologico (si pensi all’avvento dei frigoriferi, delle lavatrici, delle televisioni, solo per citare qualche esempio) provocò un’impennata dei consumi e, con essa, implementate quote di prosperità e di diminuita disoccupazione.
Anzi, la capacità di realizzare merci divenne talmente alta che il problema non fu (come era sempre stato) “produrre”, bensì “riuscire a consumare”. Si cercò così di formare – grazie al ricorso sempre più intenso alla pubblicità e a riformati stili di vita – un “uomo nuovo”, maggiormente incline allo sperpero, disincentivando (tra gli altri) il riutilizzo dei beni e la produzione in proprio di alimenti (sulle tavole degli italiani, i generi industriali presero il posto di marmellate, paste e conserve fatte in casa).
Anche la politica diede il suo fattivo contributo, adottando strategie di forte espansione della spesa pubblica foraggiata da perduranti e consistenti disavanzi di bilancio.
Tuttavia, caduto nel 1989-’91 il “pericolo comunista” e moltiplicatosi su scala planetaria il numero dei consumatori, il Belpaese perse centralità geopolitica (insieme ad altri stati, si pensi alla Grecia) e, con essa, i collegati privilegi. Con un debito pubblico straordinariamente elevato, a partire dal Trattato di Maastricht (1992) vennero attivate politiche di contenimento che comportarono imponenti tagli ai servizi e al numero dei dipendenti pubblici (in deciso calo negli ultimi vent’anni), di contro a un forte incremento della pressione tributaria (secondo i dati ISTAT, passata dal 31,4% del PIL nel 1980 al 41,9% del 1992, per quindi toccare nel 2021 la ragguardevole soglia del 43,5%).
Inoltre, alla ricerca di elevati profitti garantiti da costi della manodopera bassi, la globalizzazione ha facilitato lo spostamento di intere filiele produttive all’estero (soprattutto nei paesi ex comunisti e in Cina), con impatto negativo sull’occupazione, già fortemente provata dai tagli alla spesa pubblica, dal brusco innalzamento dell’età pensionabile e dalla c.d. “disoccupazione tecnologica”.
Dunque, certamente le condizioni che permisero lo straordinario sviluppo economico dell’Italia post bellica non esistono più. Oramai il comunismo è una flebile preoccupazione per le élites capitaliste, mentre le masse disagiate vagano tra l’apatia politica (che si traduce in mancata partecipazione alle urne per milioni di elettori) e l’adesione a “movimenti di protesta” che, almeno ad ora, giunti nella “stanza dei bottoni”, ridefiniscono in larga misura e pressoché subito, le loro (a parole) radicali battaglie, annacquandosi con quella classe dirigente che spergiuravano di combattere.
Se ciò risulta vero, perché il mio precedente articolo riportava l’idea che una ripresa economica fosse (ad alcune condizioni e in termini quantitativi senza dubbio impareggiabilmente minori rispetto a quelli conosciuti nel periodo post-bellico) possibile? Per due motivi.
Primo perché la politica – che non può tutto, ma comunque molto – ha gli strumenti per indirizzare, almeno in parte, l’andamento economico verso scelte sociali. Non ho mai affermato che si tratti di un’operazione facile, tenuto conto che l’Italia ha eccessivamente delegato la propria politica industriale (in primo luogo) alla Cina. Né ho illuso il lettore che l’attuale fase storica fosse passeggera e facile da superare (non a caso, chiudevo il pezzo con l’inciso che, in questo momento, risultasse “difficile intravvedere il sole dietro alle nuvole”). Nondimeno, so pure che altre crisi economiche di portata affatto marginale, quale quella del ’29 negli USA, furono attivamente contrastate come avvenne con il New Deal di Franklin Roosevelt (1882-1945) durante gli anni Trenta.
Secondo, se è vero che non abbia mai apprezzato gli intellettuali che ragionano in maniera avulsa dalla realtà, o peggio ancora quelli che si vendono al potere dimenticandosi del popolo, dall’altra credo che neppure i cantori di eterna sventura e i pessimisti cosmici non si rivelino buoni profeti, perché anche nelle sfide più ardue della vita è sempre bene tenere (almeno un pochino) aperta la porta alla fiducia.
Stampa solo il testo dell'articolo Stampa l'articolo con le immagini
Articolo pubblicato il 18/05/2022