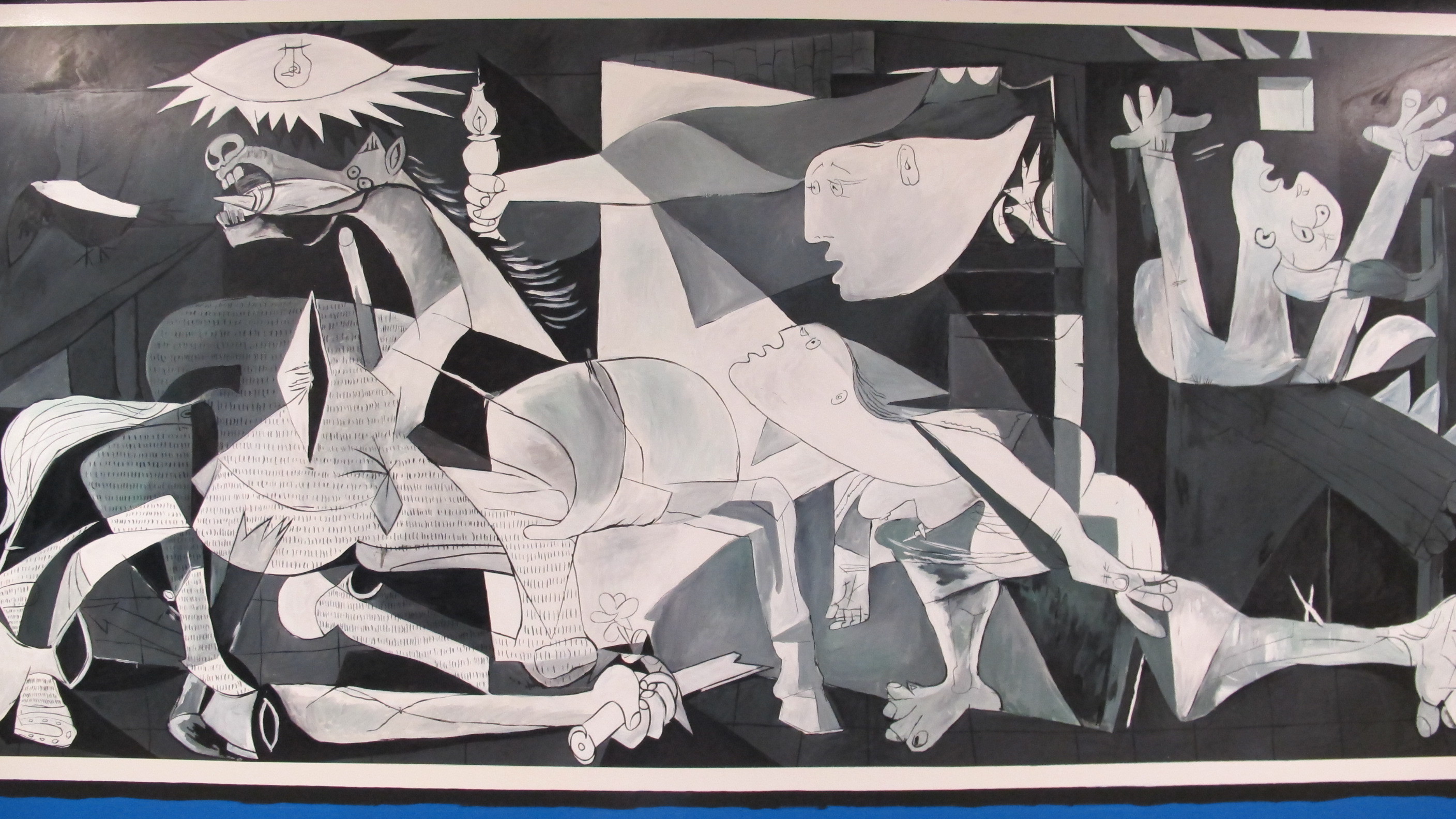Breve ritratto di un intellettuale scomodo.
Cent’anni fa – più esattamente il 5 marzo 1922 – nasceva Pier Paolo Pasolini: poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo, pittore, giornalista e linguista, ma soprattutto uomo di grande intelligenza e coraggio.
In realtà, più che nella ricorrenza della nascita, Pasolini dovrebbe essere ricordato in quella della morte, avvenuta la notte tra il 1° e il 2 novembre del 1975, quando, all’età di 53 anni, subisce un truce omicidio sulla spiaggia dell'idroscalo di Ostia.
Dell'uccisione viene incolpato un diciassettenne, noto alla polizia come ladro di auto e "ragazzo di vita", di nome Giuseppe Pelosi.
Sin da subito, però, una parte del mondo intellettuale (ad esempio Oriana Fallaci in un articolo su L'Europeo) sostiene di non credere alla versione ufficiale. Trent’anni dopo, in un'intervista televisiva rilasciata nel 2005 e per quanto da Pelosi riferito a Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza (e dai due autori riportato nel saggio "Profondo Nero" apparso per Chiarelettere nel 2009), i timori trovano conferma poiché Pelosi confessa di non essere stato l’esecutore materiale: verità in precedenza taciuta per paura di ritorsioni.
Il dietrofront di Pelosi ridà linfa alla tesi di coloro che ricollegano (pur in mancanza di prove inconfutabili) il delitto di Pasolini alla volontà di impedire l’ultimazione e la pubblicazione del libro “Petrolio” che, tra gli altri aspetti, ricostruisce il ruolo di Eugenio Cefis (1921-2004), imprenditore e dirigente d'azienda, nonché tra il ‘71 e il ’77 presidente della Montedison. Secondo Pasolini – che in “Petrolio” dettaglia gli intrallazzi economico-finanziari di Cefis – quest’ultimo avrebbe giocato un ruolo nello stragismo italiano di quegli anni, su cui Pasolini interviene in articoli importanti quali “Il romanzo delle stragi”, apparso il 14 novembre ‘74 sul “Corriere della Sera”.
Più che soffermarsi sulla morte di Pasolini – che merita attenzione anche solo per motivi di giustizia – vogliamo qui richiamare quello che Pasolini ha saputo lasciare di bello in vita. Infatti, Pasolini è un intellettuale a tutto tondo, gradevole nella scrittura, lucido nel pensiero, acuto nel cogliere, da un dettaglio, significati profondi e lungimiranti.
Il metodo d’analisi a cui Pasolini ricorre è in primo luogo rappresentato dall’osservazione. Come già fu per Alexis de Tocqueville (1805-1859), in quel capolavoro che è “La democrazia in America” (1835: I vol.; 1840: II vol.), a Pasolini basta un particolare (la pubblicità di un bluejeans, la nuova moda di tenere i capelli lunghi tra i giovani, la sparizione delle lucciole per via dell’inquinamento) per intuire articolate verità psicologiche e linee di cambiamento comportamentali in una società che, durante quegli anni, è in bulemica trasformazione.
Ma Pasolini non è solo un intellettuale fine, è anche imprevedibile e scomodo.
Imprevedibile perché, a differenza di altri, non è persona che si ingabbia in un falso (quanto comodo e in parte precostituito) clichè di “destra” o di “sinistra”. Ad esempio, il suo essere comunista non gli impedisce di esprimere una netta contrarietà all’aborto, o talvolta di muovere critiche al Partito comunista (a cui peraltro non è mai stato iscritto). Scomodo in quanto Pasolini sferra numerosi e pesanti “j’acuse” contro la Chiesa, il capitalismo, gli USA e la CIA, i partiti (specie la DC), disvelando al lettore molti degli arcana imperii del potere.
Inoltre Pasolini ha un ulteriore merito: l’aver compreso – non unico, ma certamente più di altri – l’estremo pericolo rappresentato dal conformismo consumistico che, nell’articolo “Limitatezza della storia e immensità del mondo contadino” (pubblicato l’8 luglio ’74 per “Paese Sera”), viene definito alla stregua di un “repressivo totalitarismo”.
Difatti, Pasolini è perfettamente cosciente che le innovazioni tecnologiche, i veloci e sempre più pervasivi mezzi di comunicazione (in particolare la televisione), i prodotti industriali di massa, accompagnati da uno stile di vita incentrato sul possesso dei beni (che talvolta si trasforma in idolatria) abbiano irrimediabilmente sostituito il precedente “universo contadino”, con i suoi millenari e policromi dialetti e costumi.
Per Pasolini l’edonismo consumistico è un codice convenzionale e interclassista talmente potente da riuscire ad appiattire stili di vita, accomunare forme di pensiero, uniformare mentalità. Tutto finisce per assomigliarsi: operai e borghesi, uomini e donne, giovani e anziani, meridionali e settentrionali.
L’appiattimento culturale – figlio delle televisoni, della réclame, della divinizzazione delle “cose”, di mezzi di trasporto sempre più efficenti e rapidi che mescolano popoli e tradizioni – è per Pasolini un’inedita forma di fascismo. Anzi, rispetto a quest’ultimo (scrive Pasolini ne “L’articolo delle lucciole” del 1° febbraio ’75: “I modelli fascisti non erano che maschere, da mettere e levare. Quando il fascismo fascista è caduto, tutto è tornato come prima”), è per molti aspetti ancora più pericoloso perché comporta un profondo cambiamento antropologico nella popolazione.
Tra gli altri aspetti, vittime di questo nuovo ego egemonizzante, ateo e gaudente, sprecone nella stessa misura in cui lo sperpero comporta maggiori consumi (e quindi guadagni per l’industria e i commerci) è lo “spirito religioso”. Scrive Pasolini nell’articolo “Analisi linguistica di un slogan” (Corriere della Sera, 17 maggio 1973): “Il nuovo potere borghese necessita nei consumatori di uno spirito totalmente pragmatico ed edonistico: un universo tecnicistico e puramente terreno”, piegato – a differenza delle preoccupazioni trascendentali proprie delle religioni (che, non a caso, esaltano l’umiltà, la povertà, il digiuno, il distacco dai beni materiali della terra) – alle mere esigenze del consumismo.
Anche in questo contesto, ciò che preoccupa Pasolini non è la Chiesa (la cui storia – nell’articolo “Chiesa e Potere” del 6 ottobre 1974 – viene dipinta alla stregua di un intreccio di “potere e di delitti di potere”), bensì un inquietante appiattimento di valori, capace di minare gli stessi principi fondanti del cristianesimo (non casualmente, lo sviluppo del capitalismo industriale vede accompagnarsi un significativo declino delle vocazioni e della partecipazione alle funzioni e ai sacramenti religiosi).
È una nebbia che amalgama e avvolge le molte sfaccettature della vita. Sono uomini e donne che leggono gli stessi libri, che vedono identici film, che consumano analoghi prodotti, a loro volta creati in serie, che vestono in maniera similare, che ascoltano musica diffusa in ogni parte del globo di cui spesso manco comprendendo le parole, che sperano nei medesimi sogni. Non è un caso che Pasolini, agli inizi degli anni Settanta, torni a scrivere in friulano quale forma di resistenza storica e di rinnovata riconquista della propria identità (la perdita di ricchezza che segue al tramonto dei dialetti viene definita da Pasolini una “tragedia”).
Ma forse quell’Italia – che pure in larga misura ha amato e ammirato Pasolini – non era pronta ad accogliere tante delle perspicaci riflessioni pasoliniane, un po' per preconcetto (ad esempio, per la non celata omossessualità di Pasolini), un po' perché non ne era semplicemente preparata. L’Italia era un paese che da poco aveva superato la precedente povertà (che presto si voleva dimenticare) e a cui il capitalismo consumistico dava l’idea di un raggiunto e migliore status, con i confort dell’agio offerto dalle comodità che le nuove tecnologie concedevano.
Nondimeno la riflessione di Pasolini (che pagò a caro prezzo la difesa delle proprie idee subendo ben 33 processi, tra cui quello di vilipendio della religione) merita approfondimento e meditazione, ora più che mai, in un mondo incontrovertibilmente più uniformato, globalizzato e stereotipato rispetto a quello esistente negli anni Settanta del Novecento.
Perché il bello della “grande cultura” è anche questo: non muore mai. Più che un saluto, dunque è un arrivederci.
Stampa solo il testo dell'articolo Stampa l'articolo con le immagini
Articolo pubblicato il 02/11/2022