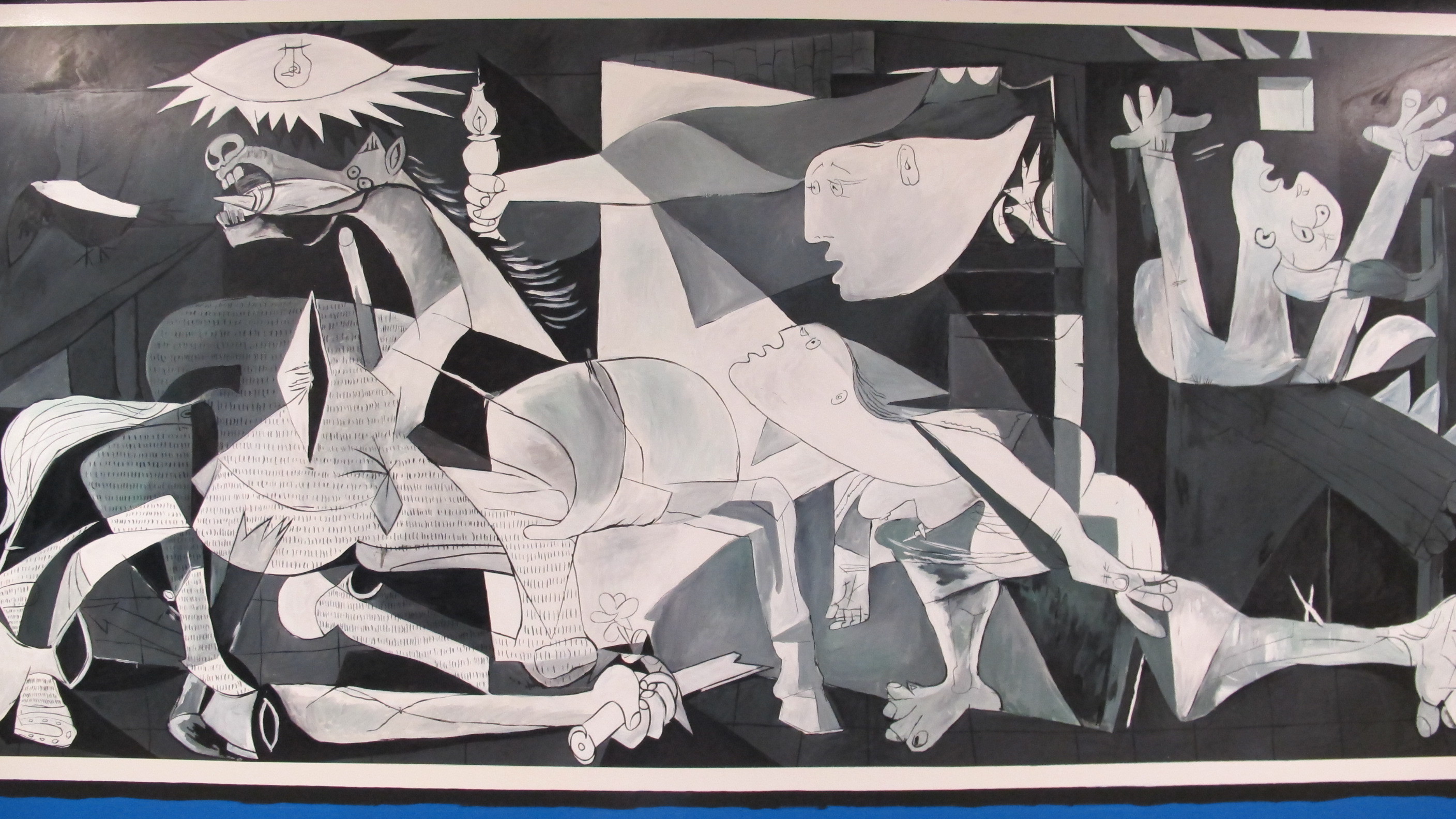Default U.S.A. ed economie fondate sui mutui
Sabato 27.05 il Presidente Joe Biden e l'ala repubblicana che vanta la maggioranza nella Camera dei Deputati hanno raggiunto un compromesso inteso a evitare il default degli U.S.A.. Da quanto si è appreso, l’intesa sospende, per un biennio, il tetto del debito americano. Al di là dei particolari, ciò che preme osservare è che, come per molti altri paesi del mondo, il debito pubblico appaia in significativa cresciuta negli ultimi decenni.
Con maggiore dettaglio e volendo fare un excursus storico, terminata la Seconda Guerra mondiale (che rappresentò un inimmaginabile sforzo finanziario per i paesi belligeranti), grazie a una sostenuta espansione economica, il debito degli Stati Uniti scese costantemente fino a raggiungere, verso la fine degli anni ’70, il 30% del PIL.
Tuttavia, il trend virtuoso si invertì, prima con Ronald Reagan, quindi con George Bush jr, a seguito di un notevole incremento degli oneri militari (dovuto alla competizione con l’URSS per Reagan e all’invasione dell’Iraq di Saddam Hussein per Bush jr), che portò il debito al 60% nel 2003.
Un ulteriore balzo in avanti fu poi dettato dalle scelte di Barak Obama volte a contenere gli effetti della crisi finanziaria del 2008, seguita al fallimento di Lehman Brothers, che condussero il debito americano a oltrepassare la soglia del 100% del PIL. Al termine del mandato di Obama, ovvero nel 2017, il debito U.S.A. era al 105%, rimanendo sostanzialmente invariato sino al primo anno di pandemia da Covid-19, quanto schizzò a oltre il 128%.
Volendo cambiare nazione e guardare a casa nostra, la storia dell’andamento del debito pubblico italiano è in buona parte simile. Terminato il conflitto mondiale, grazie a una robusta crescita economica e alla presenza di una costante inflazione, il nostro debito calò drasticamente, giungendo al 40% del PIL al termine degli anni Sessanta.
Tuttavia, nonostante la prosecuzione di un trend di crescita produttiva, per una serie di criticità e di scelte politiche tendenti a incidere sulla spesa pubblica, nei due decenni successivi il debito peggiorò, toccando la percentuale del 124% nel 1994.
Firmato nel 1992 il Trattato di Maastricht, l’Italia fu costretta a contenere le proprie uscite pubbliche, con l’effetto che nel 2007 – dunque l’anno antecedente alla crisi di Lehman Brothers – il debito pubblico venne ad attestarsi al 103%, salvo balzare al 120% appena tre anni dopo.
Infine, come negli U.S.A., ad acuire il debito, giunse il Covid e la scelta del governo di imporre il lockdown (inglesismo che, in italiano, avrebbe fatto rima con la più sgradevole locuzione di “confinamento”). In termini economici l’effetto fu devastante: al crollo dei consumi, della produzione e del gettito fiscale, si contrappose un implemento della spesa pubblica dovuto all’impennarsi delle uscite sanitarie e al moltiplicarsi di bonus e sussidi.
Il risultato fu disastroso: nel 2020 il PIL italiano scese di circa 9 punti percentuali, il disavanzo annuale peggiorò al 9,6% (a fronte di un massimo del 3% previsto dal Trattato di Maastricht), la pressione fiscale salì al 42,8% e il debito pubblico si attestò alla ragguardevole (e preoccupante) soglia del 155,6%.
Parallelamente a quanto sinora si è detto, è da tenere in considerazione un secondo fattore: pure i debiti delle famiglie e delle imprese, negli ultimi decenni, sono andati moltiplicandosi. Come ricorda Foa “nel 1980 il debito privato era pari al 73,9% del Pil mondiale”, mentre “nel 2007 ammontava al 164% […], per poi salire al 178% nel 2020” (M. Foa, “Il Sistema (in)visibile. Perché non siamo più padroni del nostro destino”, 2022, p. 56).
In estrema sintesi, dalla fine degli anni Settanta-inizi anni Ottanta del Novecento a oggi, sia i debiti pubblici sia quelli privati sono più che raddoppiati.
Che è successo? Le cifre che sopra abbiamo richiamato possono tornarci d’aiuto. Terminato il conflitto mondiale, la sostenuta crescita economica degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta ha diffuso benessere e, allo stesso tempo, permesso che i conti pubblici rimanessero “in ordine”.
La gente lavorava, risparmiava (perché gli stipendi permettevano un elevato potere d’acquisto) e, con quei soldi, comperava. Certo, i mutui esistevano, ma erano rilegati all’acquisto di beni durevoli, di importante valore economico, come la prima (o la seconda e, qualche volta, pure la terza) casa o agli investimenti per le imprese.
Poi, alla caduta del muro di Berlino, è seguita una mal gestita globalizzazione: le aziende hanno delocalizzato laddove il costo della manodopera era più basso. Di contro, anche quale conseguenza dell’aumento della quantità di debiti pubblici, la pressione tributaria è cresciuta (specie sui ceti medi) e i salari hanno iniziato a perdere potere d’acquisto.
Gli stati hanno tagliato la spesa sociale e nuove povertà sono tornate ad affacciarsi in società che le avevano sostanzialmente dimenticate.
Diminuendo la capacità di spesa, i consumi – cosa che in parte è avvenuta – si sono contratti. Che fare, dunque, in un’economia fondata sulla “bulimia dei consumi”?
Il dilemma – come coglie nuovamente con acutezza Foa – è stato risolto ricorrendo a un crescente indebitamento. Da un lato, la riduzione della capacità di generare risparmio è stata “soppiantata nel comune cittadino da quella del credito quasi senza limiti” (p. 55), anche per acquisti di modico valore. Dall’altra, gli stati hanno “sostenuto” l’economia attraverso un massiccio ricorso al debito pubblico, che talvolta – si pensi all’Italia – li ha maggiormente esposti alle turbolenze dei mercati.
A ciò, dal 2008 in avanti, si è affiancato l’intervento delle Banche centrali che, nell’intento di contrastare gli effetti della crisi finanziaria globale, hanno iniziato a “stampare moneta” (inclusa la BCE, al tempo governata da Mario Draghi), supportando e sovvenzionando un sistema bancario che altrimenti rischiava di fallire.
Inoltre, la moneta stampata dagli istituti centrali è servita anche a comprare titoli di stato che sarebbero rimasti invenduti (o, comunque, avrebbero dovuto essere collocati sul mercato a tassi d’interessi più elevati), in tal modo permettendo agli stati di contrarre ulteriore indebitamento.
Si è così venuta a creare quella che potremmo definire “un’economia dei debiti” che, se portata all’esasperazione, ha evidenti limiti. Intanto, i debiti (pubblici o privati che siano), oltre a dover essere restituiti, comportano il pagamento d’interessi, drenando preziose risorse che meglio sarebbero servite per offrire servizi, o incentivare la crescita.
Infine, è bene ricordare che il debito pubblico (specie se eccessivo nella sua quantità o nel rapporto rispetto alla produzione) non crolla finché è sostenuto della fiducia collettiva. Ma se questa viene meno – come dimostrano diversi esempi storici, quali il crollo della borsa di Wall Street nel 1929, o gli effetti del ricordato fallimento di Lehman Brothers – allora quel sistema può drasticamente e velocemente incepparsi.
Non è qui (anche per motivi di spazio) l’occasione di sviscerare rischi e strategie di rimedio. Il timore è che, a lungo andare, un’economia fondata su un eccessivo ricorso ai debiti non appaia sostenibile, anche perché, a camminare sul filo del rasoio, prima o dopo, ci si taglia.
Stampa solo il testo dell'articolo Stampa l'articolo con le immagini
Articolo pubblicato il 31/05/2023