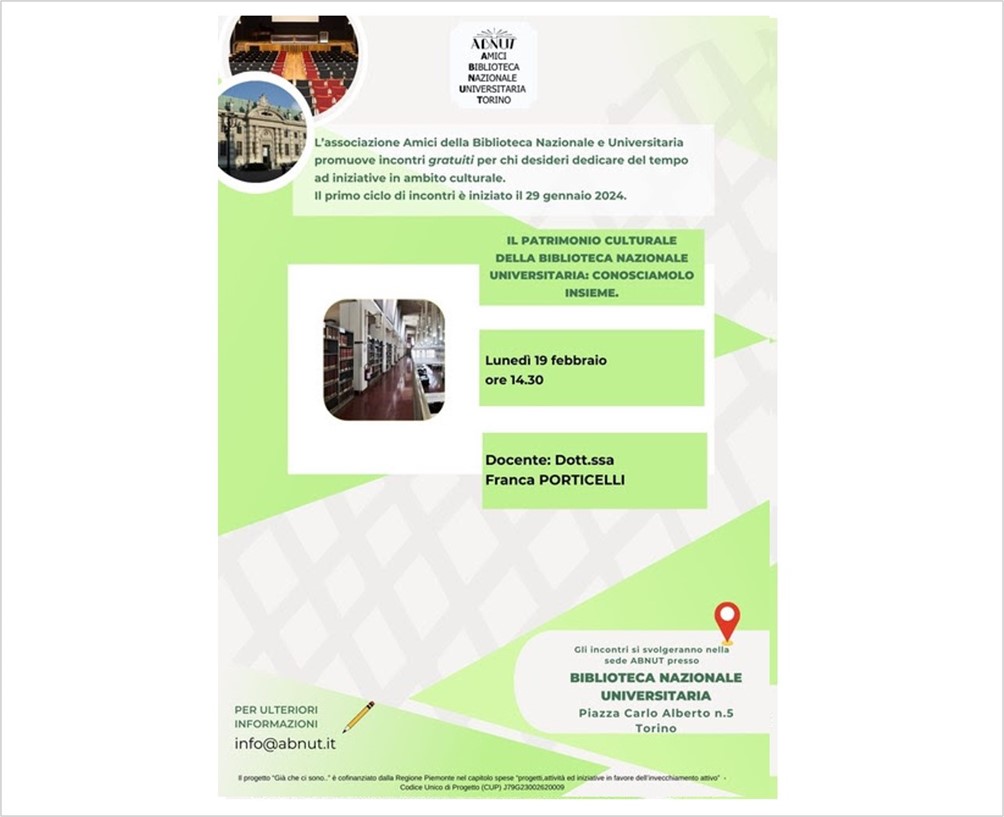Quando la "storia minore" arricchisce la "grande storia"
La cosiddetta “storia minore” è sempre stata portatrice di realtà socio-economiche particolari, di scontri tra culture inconciliabili, di conflitti circoscritti a gruppi di minoranze etniche e di altre manifestazioni che rientrano in questo genere di caratteristiche.
Tuttavia è sempre emersa la convinzione che queste “realtà marginali” e apparentemente di scarsa rilevanza, non potessero condizionare i meccanismi che determinano il corso dei grandi eventi storici.
In realtà la “storia minore” ha sempre costituito la “malta” che, integrandosi e amalgamandosi con gli eventi storici eclatanti, li ha arricchiti, consentendo a questi di diventare la “grande storia”.
Si può dire che l’importanza della “storia minore” si manifesta nel dare colore e nell’umanizzare gli eventi significativi che, per evidenti necessità didattiche, sono sempre stati “narrati” in modo semplificato e sovente con aridità nozionistica.
Tuttavia la “storia minore”, per le caratteristiche sopra citate, può costituire lo strumento di comprensione ed approfondimento di realtà sminuite nelle loro portata o tendenzialmente marginalizzate, se non oscurate, per motivazioni di opportunità storico-politica ufficiale.
E’ il caso dello “spaccato di vita socio-economica” relativo alla convivenza degli italiani con la popolazione indigena nella Libia degli anni trenta.
Storia Illustrata (supplemento al n. 2067 di Epoca del 20 maggio 1990) ci offre l’interessante articolo “Diari paralleli” di Saverio Tutino.
L’articolo, che riportiamo integralmente, merita una' attenta lettura e riflessione in quanto lo “spaccato sociale” trattato è poco noto e probabilmente da sempre “oscurato” per convenienza politica.
La realtà libica del tempo evidenziava il “colonialismo del ventennio fascista”, oggi eticamente condannabile, ma che negli anni trenta del secolo ventesimo, rientrava nella “normalità storica” da parte delle potenze europee, del mondo occidentale e orientale.

VIVERE IN LIBIA NEGLI ANNI TRENTA
L’amara delusione di due donne italiane mandate dal fascismo – con le loro famiglie – a vivere in Libia fra il 1930 e il 1940 è decumentata, in un curioso parallelo di circostanze diverse da due memorie autobiografiche, pervenute all’Archivio di Pieve S. Stefano.
Filippina Mincio nata a Como era moglie di un Segretario del Fascio, e andò due volte in Libia, prima nel 1930, poi nel 1940. Ester Morselli è nata nel 1930 e raggiunse la Libia con tutta la famiglia di braccianti modenesi nel 1938, per colonizzare la regione di Beda Littoria.
Nei due scritti c’è una comune eccitazione per la novità nel viaggio e una conclusione amarissima, ugualmente comune. In mezzo, la descrizione dei costumi di vita degli arabi diverge per la differenza d’epoca, di classe sociale e quindi anche di esperienza di vita.
Nel documento della Mincio assumono tragico risalto i cenni al martirio che veniva inflitto ai beduini ribelli. In quello della Morselli, certe notizie non compaiono perché l’epoca più apertamente repressiva non fu vissuta dai ventimila braccianti che andavano a creare quell’insediamento colonico.
La Mincio frequentava molte mogli dei notabili, ricoperte d’oro. La Morselli ricorda l’ “odore sgradevole” delle donne povere del posto. Ma tutte due concordano nel rilevare il comportamento corretto, civile e anche ospitale della popolazione araba nei confronti degli italiani.
Quando poi scoppia la guerra, la sorte colpisce in modo imparziale la moglie del Segretario del Fascio e la sorella del giovane contadino: i rispettivi marito e fratello richiamati con la “cartolina gialla” e col servizio di leva, saranno fatti prigionieri, finiranno in India e torneranno sei anni e mezzo dopo. Non rivedranno mai più la Libia facile degli anni fascisti. (s.t.)
C’era da cominciare a lavorare
Siamo partiti di sera, il giorno 28 ottobre 1938. La nostra nave si chiamava Liguria, aveva molti anni sulle spalle ed era molto lenta ( … ) dieci giorni per arrivare a Tripoli ( … ). La cosa molto bella era il vitto assicurato senza dover fare debiti. Ci siamo divertiti, specialmente noi più giovani ( … ). Quando siamo arrivati a Bengasi ( … ) fu messo a disposizione un camion per ogni nucleo famigliare ( … ). Prima di arrivare a Barce ( … ) ci siamo fermati per trascorrere la notte, e i soldati ( … ) hanno montato una tenda per ogni famiglia ( … ). Il mattino seguente abbiamo ripreso la marcia ( … ) diretti verso Beda Littoria.
A circa otto chilometri dal paese si cominciava a intravvedere qualche casa colonica e man mano che ci avvicinavamo, la scritta era in nero su bianco ( … ). Ente Colonizzazione della Libia. Le case distavano cinquecento metri una dall’altra ( … ). Quando il camion si è fermato davanti alla casa contrassegnata col n. 79 è stato un grosso sollievo ( … ) eravamo in viaggio da dodici giorni ( … ) quando siamo entrati, non credevamo ai nostri occhi: tutte le stanze erano ammobiliate, la cucina al centro col tavolo, due panche, la credenza con le provviste: pasta, olio, zucchero ( … ) c’erano perfino i fiammiferi ( … ). Le camere da letto erano tre coi rispettivi letti e il comò, il bagno alla turca, il forno per cuocere il pane ( … ). Ci sembrava una reggia ( … ).
Finita la sorpresa ( … ) c’era da cominciare a lavorare ( … ). Prima cosa che hanno fatto ( … ) io ero troppo piccola per poterli aiutare, hanno arato la terra per poter seminare ( … ). Gli arabi seminano solo un po’ d’orzo per fare il loro pane, ma è gente che mangia poco perché lavora anche poco ( … ). Quello che fanno di buono è il tè e ne bevono moltissimo ( … ) noi non riusciamo a farlo così saporito. Lo passano da una brocca all’altra ( … ) non è neanche da confrontare con quello che facciamo noi ( … ).
Avevamo cominciato una nuova vita, il cibo non mancava, c’era la tranquillità famigliare, il lavoro era assicurato ( … ). I giovani si trovavano spesso a casa dall’uno o dall’altro ( … ). A mio padre piaceva molto abitare là perché quando aveva tempo andava a caccia ( … ). Alle volte arrivava sino al mare che distava circa trenta chilometri ( … ). Certe volte si imbatteva in qualche tenda abitata da arabi e lo chiamavano dentro per offrirgli il tè e fare quattro chiacchere ( … ).
Gli arabi si comportavano bene nei nostri confronti ( … ) le loro mogli venivano a venderci le uova ( … ) e i fichi d’India ( … ). L’arrivo delle arabe si sentiva a qualche metro di distanza perché emanavano un certo odore sgradevole, molto probabilmente si lavavano poco e portavano molto tempo gli stessi indumenti ( … ). A rompere questa tranquillità è stata la seconda guerra mondiale dichiarata il 10 giugno 1940.
Mio fratello Irio era già partito il 10 gennaio perché era di leva ( … ). Dopo poco è scoppiata la guerra, è rimasto prigioniero a Tobruk, portato in un primo tempo in Egitto, poi in India e infine in Inghilterra dove è rimasto fino alla fine della guerra e oltre, perché è rientrato in Italia un anno e più dopo la fine (… ).
La famiglia continua a sgretolarsi, io che alla dichiarazione della guerra avevo dieci anni, il giorno 10 giugno sono partita per l’Italia assieme a tanti altri ragazzi di età dai quattro ai quattordici anni. Ester Morselli
Ogni ribelle finiva sulla forca
Partimmo per l’Africa con una nave tutta bianca. Da bambina avevo sempre sognato di fare un viaggio per mare ed ero felice di poterlo realizzare ( ... ). Quando il piroscafo giunse a Bengasi ( … ) sulla banchina del molo, centinaia di arabetti vocianti offrivano ai passeggeri souvenir ( … ). Qualche giorno dopo partimmo per l’interno ( … ). Barce era uno dei maggiori centri dell’interno. Il deserto cominciava sotto il marciapiedi di casa nostra ( … ). Il governo aveva fatto costruire un villaggio composto da villette, destinato ad alloggi per impiegati ed ufficiali. Erano piccole, composte da due camere e servizi ed un piccolo giardino intorno ( … ). Passammo la nostra luna di miele in quella villetta e ci vivemmo felicemente per due anni ( … ). A quel tempo in Cirenaica c’era ancora la ribellione. I beduini che non avevano voluto aderire al Governo Italiano si erano ritirati nel deserto. Di notte assaltavano i paesi razziando, saccheggiando e mettendo a fuoco. Tutte le famiglie italiane avevano in dotazione un moschetto ( … ). Poi il Generale Graziani istituì la pena di morte ( … ). Ogni ribelle che veniva catturato con le armi in pugno finiva sulla forca. Lo spalmavano di pece e penzolava sinistramente per otto giorni ( … ).
Gli arabi abitavano i loro quartieri vicino ai nostri, ma non ci davano alcun fastidio ( … ) vi era poi una colonia di Ebrei che si occupavano di commercio e avevano ricchi negozi ( … ). I negri abitavano in zone lontane dagli arabi e venivano ritenuti esseri inferiori ( … ). Gli arabi coltivavano l’orzo che era il loro maggiore nutrimento ( … ).
Le donne arabe allora non uscivano di casa, ma la signora Fornari le conosceva e mi condusse ( … ). Avevano i capelli raccolti in diecine e diecine di treccine legate con fiocchetti rossi ( … ), le unghie delle mani e dei piedi dipinte a striscioline orizzontali ( … ), ma ciò che mi fece rimanere a bocca aperta erano i monili che portavano addosso. Si trattava di chili d’oro ( … ) alle caviglie ( … ) ai polsi ( … ) alle orecchie ( … ) quando muovevano la testa o ridevano era tutto un tintinnio ( … ) intorno al collo lunghe collane di monete d’oro ( … ). Io piacqui molto alle mogli del notabile ( … ) passarono alla preparazione del tè. In una grande teiera misero le foglie del tè di due tipi, verde e nero ( … ) poi ci offrirono delle ciambelline dolci intinte nel miele. Ma io avevo visto che la vecchia signora madre del notabile le aveva disposte nel vassoio prendendole con le mani e non volli accettarle ( … ).
Con la conquista dell’Impero un altro dispiacere mi attendeva. Per meriti di servizio mio marito fu mandato ad aprire alcuni uffici nell’Impero d’Etiopia. Partì per Gondar solo ( … ). Cominciai a smaniare e a disperarmi ( … ). Mi recai a Roma ( … ). Pensai di rivolgermi a donna Rachele Mussolini ( … ) le dissi che volevo stare vicino a mio marito ( … ). Due mesi dopo riabbracciavo mio marito ( … ) ed il 21 aprile del 1940 sbarcammo per la seconda volta a Bengasi. Io aspettavo il terzo bambino. Questa volta a Bengasi c’era il porto ( … ). Trovammo un appartamento molto grande con tante camere ( … ) la nostra serenità durò ben poco. Il pericolo di una guerra era imminente ( … ). Mi ricordo come ora di quel pomeriggio.
Avevamo portato il bambino ai giardini pubblici. Vittorio, ad arte, fece spuntare dalla tasca un lembo della sua cartolina gialla (… ) partì per il fronte il 5 giugno del 1940. Filippina Mincio
Le narrazioni sopra riportate rientrano chiaramente in quelle “storie minori” destinate all’oblio. Il problema è quante altre di queste sono e saranno destinate a questa sorte?
Importante sarebbe riflettere su questa realtà.
© 2023 CIVICO20NEWS - riproduzione riservata.
Stampa solo il testo dell'articolo Stampa l'articolo con le immagini
Articolo pubblicato il 29/07/2023