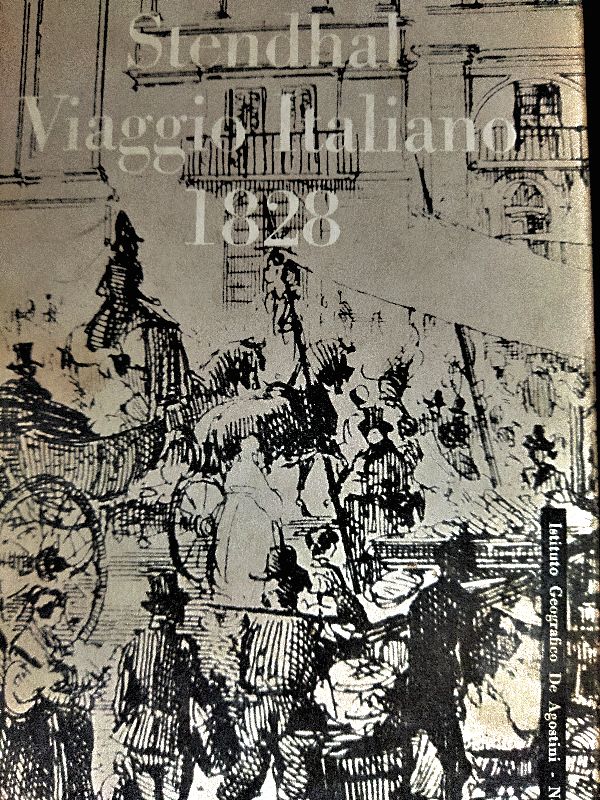Eleonora Duse - Ritratto di Vittorio Corcos
Eleonora Duse - Ritratto di Vittorio Corcos
Due artisti ricordati in tono minore nella nostra città
 Una inquieta notte torinese di Eleonora Duse.
Una inquieta notte torinese di Eleonora Duse.
A Torino, la breve via che oggi porta il suo nome si è chiamata in passato vicolo del Montone, scomparsa con il rifacimento del primo tratto di via Roma, eseguito tra il 1931 e il 1933, da piazza San Carlo a piazza Castello; prima di allora, il vicolo non raggiungeva via Maria Vittoria.
Il vicolo del Montone, appartenente alla Torino romana, anche se collocato fra edifici prestigiosi e nei pressi del “salotto di Torino”, è un luogo malfamato, dal quale si accede a vecchie case fatiscenti. Come altre vie torinesi, ha preso nome dall’albergo che vi sorgeva, all’insegna del Montone d’Oro, poi divenuto un postribolo di bassa categoria. Così lo ha descritto Milo Julini in un suo articolo, dal titolo “Povera Temi, trascinata in Suburra!” Civico20News - La «Torino noir» vista e narrata da Milo Julini.
Eleonora trascorre l'infanzia tra il nomadismo e il dilettantismo della compagnia girovaga del padre, Alessandro Vincenzo Duse (1820-1892) e della madre Angelica Cappelletto (1833-1906), calcando le scene fin da bambina.
C’è una pagina sofferente e poco nota della vita di Eleonora Duse, che la lega indissolubilmente alla nostra città. Nel gennaio 1880 arriva a Torino, scritturata l’anno prima come seconda attrice dalla Compagnia Semistabile di Torino di Cesare Rossi. Ha 21 anni, un’infanzia e una giovinezza trascorse sui palcoscenici di provincia al seguito del padre, un successo nazionale recente ottenuto con la Teresa Raquin di Zola. Prende alloggio in una locanda in Vicolo del Montone, a fianco del Teatro Carignano, nella piccola via che oggi porta il suo nome. Sulla scena esprime tutta la sua sensualità, ma quando cala il sipario è una donna disperata. Nei mesi precedenti, a Napoli, ha incontrato il primo amore, Martino Cafiero, direttore del Corriere del Mattino, un uomo affascinante che ha vent’anni più di lei, figura di rilievo nella società napoletana dell’epoca. Quando Eleonora scopre di essere incinta, Cafiero si raffredda, teme uno scandalo e la abbandona con toni sbrigativi. Ed è così che lei accetta la proposta dell’impresario Rossi, che ha affittato il Teatro Carignano. Al suo arrivo a Torino scrive all’uomo che l’ha lasciata e usa toni accorati: «Salvami da questa spaventosa nemica che mi persegue e mi opprime, salvami dalla solitudine che è qui nel silenzio della mia camera». La gravidanza procede e lei scrive ancora al padre ingeneroso: «Ma pensa, pensa a quel che, in me, è tuo. O Martino! È questo l’amore? È questo il padre…?». Alla compagnia teatrale tace il suo stato, che con il passare delle settimane diventa impossibile celare. Alla sofferenza sentimentale si aggiunge il timore di essere allontanata e perdere le 7250 lire di ingaggio, unico suo sostentamento.
Una sera, dopo lo spettacolo, Eleonora si incammina da sola per le strade torinesi. Ricorderà questo fatto, molti anni dopo, in un’intervista: «Vagai per Torino, nei quartieri pieni di silenzio e senza luce, poi in quello delle donne di malaffare, poi fino alle rive del fiume». Una giovane donna che cammina sola di notte rischia di essere fermata dalle Guardie di Città, portata in carcere e schedata come prostituta. Lei lo sa, ma non le importa, ha altri pensieri per la testa, affiora perfino l’idea del suicidio: «Vidi l’acqua scura che scorreva sotto di me, e non ebbi il coraggio. Allora tornai indietro. Rientrai nella locanda che era l’alba: raggiunsi la mia stanza e mi lasciai cadere sul letto, senza forze, gelata dal freddo». Quando il suo stato si fa evidente a tutti, l’attrice trova un’inattesa solidarietà da parte della Compagnia di Rossi e un contatto per partorire in un luogo tranquillo, a Marina di Pisa. Gli altri attori le sono di aiuto anche a raccogliere la somma necessaria per affidare il neonato a un orfanotrofio: le logiche (e il perbenismo!) del tempo prevedono che se una donna non ha i denari necessari, per oltre un anno è tenuta a prestare servizio come balia nell’orfanotrofio, costretta ad allattare altri neonati e non il proprio. Lo sfortunato figlio di Eleonora vive solo poche settimane; lei tornerà presto al teatro, ma quella notte d’angoscia a Torino resterà per sempre nella sua memoria.
D’Annunzio, inventivo creatore anche a Torino.
A D’Annunzio era stata intitolata, nel marzo 1939 la prima parte di corso Francia, da piazza Statuto a piazza Bernini, come ricordato sul quotidiano La Stampa del 10 marzo 1939, a p. 2. Nel secondo dopoguerra quell’intitolazione è stata cancellata. Oggi esiste una via che ricorda D’Annunzio, una tortuosa stradina che da via Spalato arriva al Giardino dedicato ai Caduti di Cefalonia e Corfù, ai margini di Borgo San Paolo.
Il 25 gennaio 1901, al Teatro Regio si esibisce un oratore di eccezione. A declamare i versi de “La canzone di Garibaldi” sul maggior palcoscenico torinese è lo stesso autore, Gabriele D’Annunzio. La poliedricità del suo carattere e dei suoi comportamenti gli ha già fatto guadagnare tra i contemporanei il soprannome di “vate”. In ogni caso, egli può essere a buon diritto considerato uno dei primi “divi” in Italia, nel senso moderno del termine. A Torino, D’Annunzio regalerà tre nomi coniati dalla sua fantasia.
Il film “Cabiria”.
Girato a Torino negli stabilimenti sulla Dora Riparia, è il più lungo film italiano prodotto dei suoi tempi (3.364 metri di lunghezza circa per tre ore e dieci minuti di spettacolo) e di gran lunga il più costoso: un milione di lire-oro, a fronte del finanziamento medio per un film dell'epoca di cinquantamila lire, con scene girate anche in Tunisia, in Sicilia, sulle Alpi (nelle Valli di Lanzo, dove si diceva che fosse passato Annibale) e ai laghi di Avigliana. La versione originale era virata a colori in dodici tonalità diverse, alcune inedite. Pastrone vuole al suo fianco, come sceneggiatore, Gabriele D'Annunzio, che accetta l'incarico per ripianare parte dei propri debiti. E’ lui a ideare il nome "Cabiria", "nata dal fuoco", e a volerlo come titolo della pellicola, in quanto nome della protagonista che il dio Moloch intende sacrificare. In realtà, sebbene l'intera sceneggiatura sia attribuita a D'Annunzio, il poeta si limita ad inventare i nomi dei personaggi e a comporre le auliche didascalie.
La Saiwa.
Nota per i suoi salatini e snack salati, la Saiwa ha una storia che inizia in Liguria ai primi del Novecento per poi spostarsi in provincia di Alessandria, cuore della produzione dei suoi prodotti. Tutto nasce nel 1900: Pietro Marchese apre in via Galata, a Genova, una pasticceria dedicata ai dolci conosciuti durante un viaggio in Gran Bretagna, i sugar wafer. Con gli anni la sua piccola bottega ottiene un certo successo e riesce ad ampliare la distribuzione, iniziando una delle prime produzioni industriali italiane di prodotti da forno. Nel 1920, la pasticceria si trasferisce a Torino, in corso Giulio Cesare, e il 20 dicembre 1922 diventa S.A.I.W.A, cioè Società Accomandita Industria Wafer e Affini, nome suggerito da Gabriele D’Annunzio.
Il tramezzino.
Siamo nel 1926, D’Annunzio è di nuovo a Torino e chiede un vermouth, seduto ai tavolini del bar Mulassano. La bevanda gli viene servita con alcuni stuzzichini che la titolare, la signora Nebiolo, ha ideato sotto la Mole dopo il suo ritorno dall’America, dove ha fatto fortuna. Si tratta di piccoli panini a forma triangolare, ripieni. D’Annunzio è uomo di molteplici e forti appetiti: gli piacciono e ne chiede ancora, coniando il nuovo termine di “tramezzini”.
Risulta evidente, da questi episodi torinesi, che per lui dispensare neologismi è facile, anche quando è in difficoltà a pagare il conto.
Stampa solo il testo dell'articolo Stampa l'articolo con le immagini
Articolo pubblicato il 17/02/2023