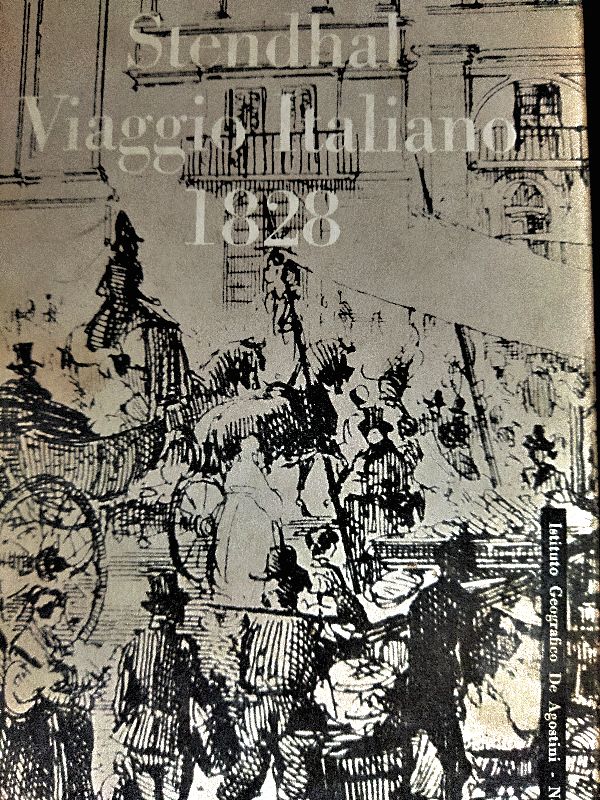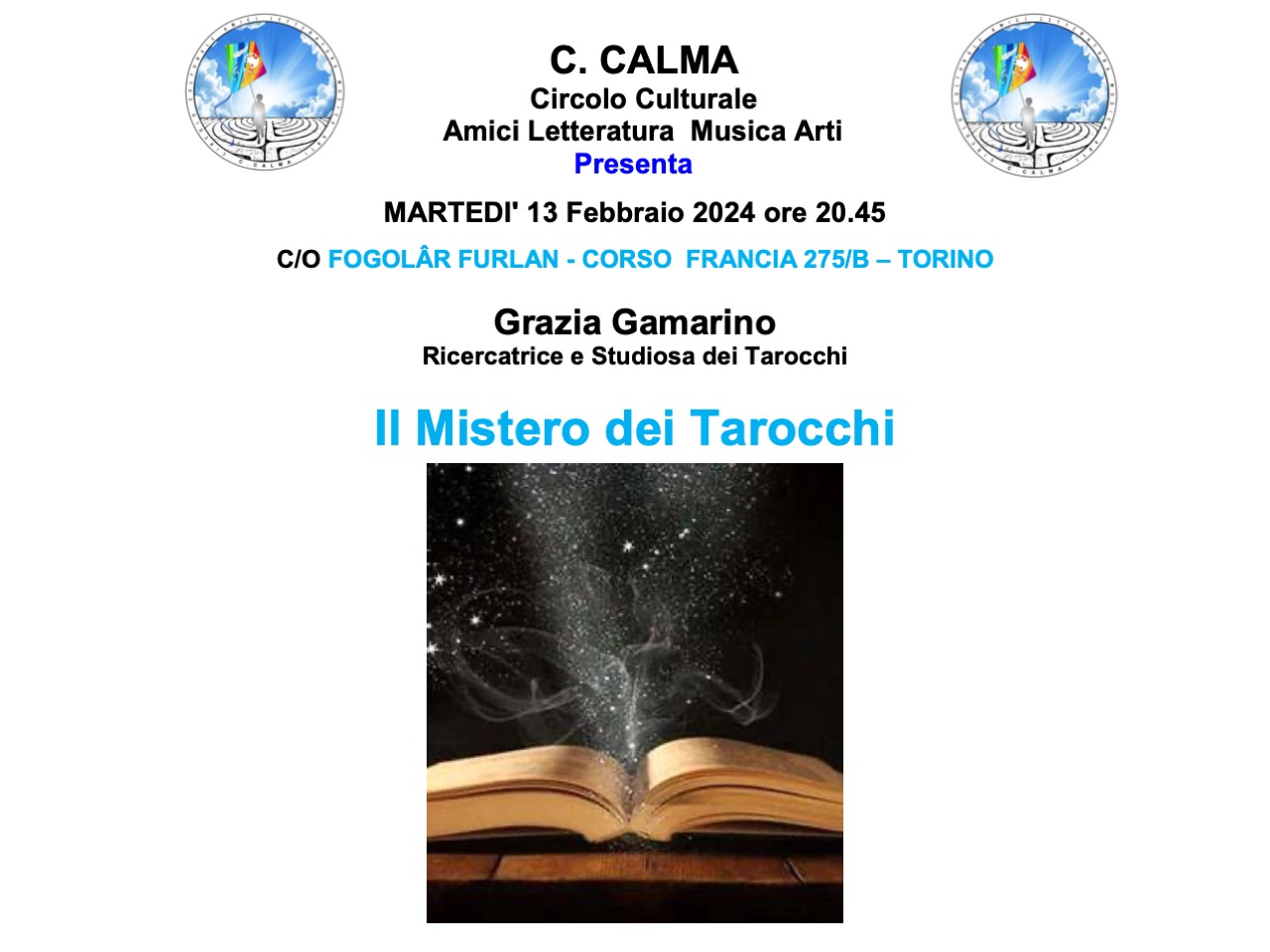Misteri ottocenteschi in una via sopravvissuta al Medioevo
Se percorriamo via XX Settembre dal centro in direzione del Duomo, l’ultima via sulla sinistra ha un nome antico: Cappel Verde. Questa stradina, una delle poche rimaste della Torino medievale, prende il nome dall’insegna di un albergo che inalberava quale insegna un curioso copricapo verde. Nei vicoli di Torino si raccontava che il locale fosse infestato da un fantasma di donna, che provocava rumori e vibrazioni, spostamenti di mobili e suppellettili. I tentativi di cacciare l’oscura presenza, anche con l’intervento di un sacerdote esorcista, non sortirono effetto.
Nel 1631 il Cappel Verde ha come titolare tale Lionardo Giordano che ottiene un incarico di fiducia dalla Corte: il Duca Vittorio Amedeo I lo invia a Chieri, nel convento di San Domenico, a prelevare oggetti di sua proprietà che vi aveva portato l’anno precedente, quando molti fuggivano dalla città e cercavano di salvare se stessi e qualche bene di fronte al dilagare della peste.
Nel 1725, un altro hoste del Cappel Verde, Domenico Desù, fornisce per undici giorni vitto e alloggio ai familiari del Re di Polonia, Augusto di Sassonia (1). Da queste due vicende si può dedurre che il Cappel Verde godesse di buona fama presso la Corte e la nobiltà torinesi.
Nella stessa strada vi era un altro albergo, detto delle Tre Picche, nella casa in cui era ubicato il collegio dei cantori del Duomo. E ancora: un diavolo inciso nella pietra e dipinto con le corna rosse era posto in una nicchia nel cortile di una casa; andrà in pezzi alla fine del 1942, sbriciolato da una bomba sganciata durante una incursione aerea, in una nube di polvere che poteva far pensare allo zolfo del diavolo.
In questo contesto è vissuta Enrichetta Naum, l’unica donna esorcista nella storia di Torino: nata nel 1843, trascorre gran parte della sua vita al secondo piano di via Cappel Verde 6. La sua fama inizia a svilupparsi nell’ultimo ventennio dell’Ottocento, quando clienti e pazienti si rivolgono a lei ritenendola, oltre che esorcista, una guaritrice capace di liberare dai mali che i medici non riescono a individuare e a curare. La donna pratica strani riti, dopo aver fatto bollire intrugli diversi in pentole da cui fuoriescono vapori e vampate, mentre lei pronuncia frasi dal significato oscuro. Quando si verifica una guarigione, accompagna il paziente per una preghiera di ringraziamento nella vicina chiesa del Corpus Domini, costruita sul luogo in cui il 6 giugno 1453 avviene il miracolo eucaristico di Torino.
Può sembrare strano che una donna, nella città capitale dello Stato sabaudo, compia atti riservati al magistero sacerdotale. In Piemonte si annoverano altre vicende simili, ma sempre nelle campagne o sui monti.
In merito alle capacità di guaritrice si può pensare che lo abbia acquisito per trasmissione familiare, una sapienza antica che si tramandava in segreto da madre a figlia; in fin dei conti, le cosiddette masche sono una figura di rilievo nel folclore, nella credenza e nell’immaginario popolare piemontese.
Riguardo alle conoscenze e pratiche di esorcista non possiamo formulare ipotesi attendibili. Il suo modesto ceto sociale non consentiva affiliazioni a società segrete o sètte; il suo basso livello di istruzione non fa propendere verso lo studio di testi e libri magici o iniziatici.
Enrichetta Naum conosceva e recitava a memoria formule di esorcismi latini che pronunciava con tono ispirato e gli occhi socchiusi, probabilmente senza conoscerne il significato.
Si racconta dalle cronache dell’epoca di un ragazzo di quattordici anni, Giuseppe Brossa, che abitava vicino al mercato di Porta Palazzo: catturato dal demonio che gli faceva compiere atti strani e lo costringeva a pronunciare parole impensabili per un ragazzo della sua età. La mamma, consigliata dalle vicine di casa, lo porta dalla Naum, la cui fama doveva già essere notevole, invece che dal parroco.
Nelle camere di via Cappel Verde il giovane viene fatto inginocchiare sul pavimento di mattoni, Enrichetta pronuncia le sue arcane formule, s’interruppe e mette a bollire un pentolino d’ acqua con erbe che profumano la stanza di tiglio ed incenso. Dopo una decina di minuti il giovane inizia a smaniare, dalla sua bocca esce bava color verde: la Naum, guardandolo negli occhi, lo afferra per i capelli e intima al demonio di abbandonare quel corpo e di rifugiarsi nel pentolino con le erbe e l’infuso bollente. Pochi istanti dopo, il ragazzo è a terra con il volto bianco e sudato, in casa si ode un botto e il pentolino traballa sul fuoco e si versa sul pavimento tra le fiamme; il ragazzo ritorna a casa liberato dal maleficio.
I vicini si lamentano del frequente via vai di clienti, di giorno e anche di notte, infastiditi anche dai rumori e dai fumi che provengono dall’alloggio di Enrichetta. Nel 1898 la donna si trasferisce in una soffitta di via Garibaldi, dove continua i suoi esorcismi, nonostante una grave forma di artrosi, ma le critiche e i pettegolezzi su di lei non finiscono. C’è chi asserisce che gli esorcismi non siano opera sua ma del marito Gaetano, costretto a rimanere nell’ombra in quanto lavora vicino al seminario in una piccola fabbrica di candele che rifornisce anche il duomo. Qualcuno pensa che lui avrebbe insegnato alla moglie i rituali e le formule, apprese da manoscritti presenti nella biblioteca del seminario; lei compirebbe gli esorcismi dietro sua ispirazione. Gaetano muore pochi anni dopo il trasferimento in via Porta Palatina, la vedova continua a esercitare le sue pratiche. La clientela aumenta con il passare del tempo e non risulta che la Naum abbia mai avuto noie con il clero, era una assidua frequentatrice della chiesa del Corpus Domini.
Muore nel 1911, all’età di 68 anni. In poche righe di cronaca La Gazzetta del Popolo annunciò la sua morte qualche giorno dopo lo svolgimento dei funerali. La sua scomparsa avviene nei giorni della Grande Esposizione di Torino. Mentre si celebra dello sviluppo delle nuove tecnologie e della moderna Torino industriale, con lei scompare l’affresco di una vecchia Torino che ora non esiste più.
Pochi anni prima, alla fine dell’Ottocento, il piccone risanatore (o fu un piccone demolitore?) umbertino abbatte la Casa del Vescovo (2), in via Porta Palatina 20 dove, nella prima metà del Seicento, dimorava il vescovo Antonio Provana, un edificio cinquecentesco, nonostante l'opposizione di Riccardo Brayda (3); il soffitto del salone al primo piano e due stemmi della famiglia Provana vengono recuperati e portati al Museo Civico di Torino. Quel piccone elimina molte antiche vie che si trovano nei dintorni del duomo e Torino perde gran parte del suo residuo patrimonio medievale; sono distrutti vicoli come la contrada del Cappel d’Oro e della Corona Grossa, i vicoli dei Pellicciai e dei Pasticcieri, quello dei Panierai e del Bastion Verde, e di loro non sono rimaste che la memoria e qualche rara fotografia. Ogni via aveva una sua storia, ma non è questa l’occasione per dedicarci ad un approfondimento su ciascuna di esse.
Via Cappel Verde si salva dallo sventramento e ancora oggi conserva in parte il suo antico fascino e ci racconta la storia segreta di Enrichetta Naum, l’esorcista torinese, che parlava solo in piemontese e riusciva a farsi capire da tutti, alla continua ricerca della salute del corpo e della mente.
Nella coesistenza di bene e male, bianco e nero, tipica di Torino, anche via Cappel Verde ha avuto il suo delitto; nel 1887, mentre Enrichetta presta le sue arti di esorcista, la strada è teatro di un inspiegabile fatto di sangue: il capitano Lorenzo Capello pugnala a morte suo fratello, per questo reato viene condannato a morte.
Note
(1) Augusto II di Polonia, detto il Forte (Dresda, 12 maggio 1670 – Varsavia, 1º febbraio 1733), duca e principe elettore di Sassonia, con il nome di Federico Augusto I, e re di Polonia con il nome di Augusto II di Polonia.
(2) Della Casa del Vescovo restano solo le fotografie scattate da Secondo Pia prima della demolizione e i rilievi di Riccardo Brayda. La sua denominazione è dovuta allo stemma presente sul portale, della famiglia Provana di Leynì. Di questa famiglia, Antonio Provana è vescovo di Torino tra il 1632 e il 1640.
(3) Riccardo Brayda (Genova, 27 dicembre 1849 – Torino, 11 ottobre 1911), architetto e studioso d'arte e architettura piemontese medievale, noto soprattutto per il suo contributo al Borgo Medievale di Torino, di cui è coordinatore dei lavori sotto la supervisione di Alfredo D'Andrade, e la costruzione di alcuni importanti palazzi torinesi: l’Ospizio di Carità, il Palazzo per l'Esposizione Generale Italiana del 1884. A lui si devono il restauro del mastio della Cittadella e la lapide dedicata a Filippo Juvarra a Superga.
© 2023 CIVICO20NEWS - riproduzione riservata
Stampa solo il testo dell'articolo Stampa l'articolo con le immagini
Articolo pubblicato il 08/09/2023