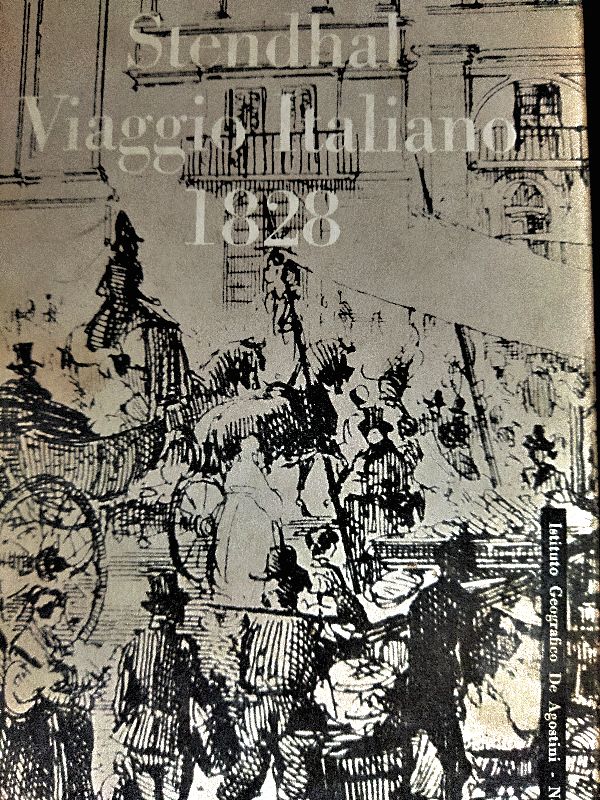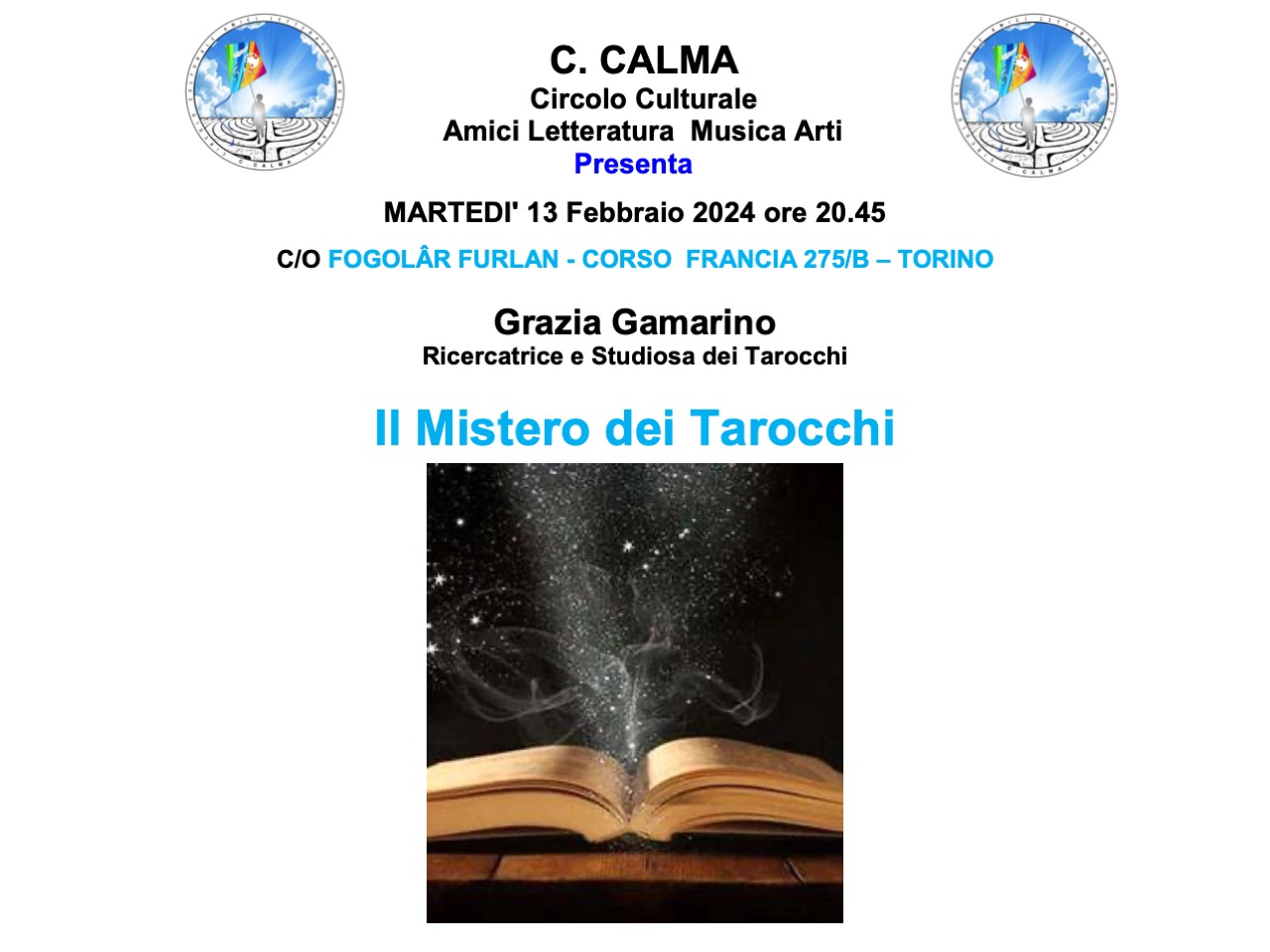Un quartiere, una chiesa, un quadro trafugato
Pietro Abate Daga, nel suo libro Alle porte di Torino (Torino 1926, Italia Industriale Artistica) ci descrive la situazione di corso Moncalieri negli Anni Venti del Novecento, già arteria trafficata, all’interno di un quartiere in rapida trasformazione.
«La maggior estensione dello sviluppo edilizio in questo punto della città si è manifestato oltre il ponte Isabella, per ragioni complesse: qui la falda della collina si allarga in terreni di più dolce declivio, e quindi di più facile fabbricazione, qui è più intenso il movimento perché punto di affluenza, quasi obbligato, di tutte le comunicazioni delle regioni del mezzogiorno con Torino, qui, infine, la salubrità e l’amenità del luogo hanno richiamato quella parte della popolazione che, costretta a cercare alla periferia più economiche abitazioni ha preferito unire all’utile il bello.
Così è sorto e si è sviluppato il borgo del Pilonetto, invadendo non solo i lati della strada di Moncalieri, ma spingendosi su per quella di Cavoretto, insinuandosi in ogni palmo di terreno rimasto disoccupato tra villa e villa».
Per quale motivo vi era tanto traffico, già a quei tempi, in una zona ancora agricola e residenziale? Seguiamo ancora la descrizione di Abate Daga.
«E’, infatti, invalsa l’abitudine dei carrettieri di percorrere la via costeggiante la collina per sfuggire all’affollamento della barriera di Nizza. Tutto questo carreggio, che per forza viene a trovare, quale sbocco naturale, la barriera Piacenza, arriva alla barriera strozzato da una strada che vorrebbe essere un corso, che dovrebbe effettivamente servire quale corso, ma finora lo è soltanto nel desiderio di quanti assistono a quello spettacolo. Le difficili condizioni del transito sono ancora aggravate dalle linee delle tranvie urbana e intercomunale, dal continuo passaggio di automobili, di ciclisti, di ogni sorta di veicoli, con pericolo continuo di investimento dei pedoni».
 Un quadro nient’affatto sereno, ben lontano dall’immagine di una città del bel tempo andato, con un corso non meno congestionato di oggi da una congerie di mezzi circolanti senza semafori o linee orizzontali di demarcazione. E cosa succedeva nel quasi perpendicolare corso Sicilia? Concludiamo l’excursus territoriale di Abate Daga.
Un quadro nient’affatto sereno, ben lontano dall’immagine di una città del bel tempo andato, con un corso non meno congestionato di oggi da una congerie di mezzi circolanti senza semafori o linee orizzontali di demarcazione. E cosa succedeva nel quasi perpendicolare corso Sicilia? Concludiamo l’excursus territoriale di Abate Daga.
«Concatenata alla questione del corso Moncalieri è quella del corso Sicilia. Il corso Moncalieri incassato come è fra la collina ed il Po non ha possibilità di sfogo alcuno. E’ necessario, invece, ritengono gli abitanti del Pilonetto, che sia fiancheggiato da altre strade e da altri corsi, che possano, comunque, e sotto diverse forme, sfollare l’eccessivo agglomerato di passaggi che per forza di cose avviene sul corso stesso. In primo luogo, il corso Sicilia, cessando di essere soltanto un tracciato per diventare, invece, un qualche cosa di concreto, potrebbe offrire alla regione del Pilonetto ed alla città di Torino molteplici vantaggi di sfollamento del corso Moncalieri, di sviluppo edilizio, di aumento di popolazione del borgo».
Corso Sicilia non è stato realizzato come auspicava Pietro Abate Daga, assolve comunque ad una funzione di sfogo del traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia.
Un’oasi di pace e tranquillità esisteva già allora, nel quartiere: la chiesa della Madonna Addolorata, detta “del Pilonetto“, al numero 227 di corso Moncalieri.
 Chiusa da una cancellata al livello della strada, ha una facciata in mattoni a vista e vi si accede salendo pochi gradini che conducono all’accesso. L'interno presenta una armoniosa e geometrica bellezza. Siamo al cospetto di un santuario, voluto da Michele Bert, aperto al pubblico nel 1891, originariamente affidato all’Ordine dei Servi di Maria.
Chiusa da una cancellata al livello della strada, ha una facciata in mattoni a vista e vi si accede salendo pochi gradini che conducono all’accesso. L'interno presenta una armoniosa e geometrica bellezza. Siamo al cospetto di un santuario, voluto da Michele Bert, aperto al pubblico nel 1891, originariamente affidato all’Ordine dei Servi di Maria.
Sul sito dell’edificio di culto l'edificazione avviene su progetto di Antonio Candelo e Corrado Gay. Secondo il Politecnico di Torino, Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, il suo autore è Giuseppe Gallo, noto costruttore di edifici di culto di stile eclettico tra fine Ottocento e inizio Novecento.
 Dipendente dalla chiesa di San Vito, viene eretta in parrocchia nel 1914 per volontà di monsignor Agostino Richelmy, Arcivescovo di Torino.
Dipendente dalla chiesa di San Vito, viene eretta in parrocchia nel 1914 per volontà di monsignor Agostino Richelmy, Arcivescovo di Torino.
Dal 2001 è affidata a sacerdoti diocesani. Nella chiesa si conserva una copia del dipinto “Madonna della Pietà”, che ha una storia particolare L’originale viene donato alla chiesa, nel 1898, da Candida Genovese, per grazia ricevuta. Secondo le cronache dell’epoca, sarebbe stata la Vergine, apparsa in sogno alla donna miracolata, a chiedere che il quadro venisse esposto in questa chiesa, di cui la Genovese non conosceva l’esistenza.
Il dipinto originale verrà trafugato nel 1977, al momento non è stato ritrovato.
Dopo le sue dimissioni per motivi di salute, l’ex Arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, ha trasferito la sua residenza in zona Pilonetto, dove continua il suo ministero sacerdotale presso la parrocchia.
© 2023 CIVICO20NEWS - riproduzione riservata
Stampa solo il testo dell'articolo Stampa l'articolo con le immagini
Articolo pubblicato il 22/09/2023