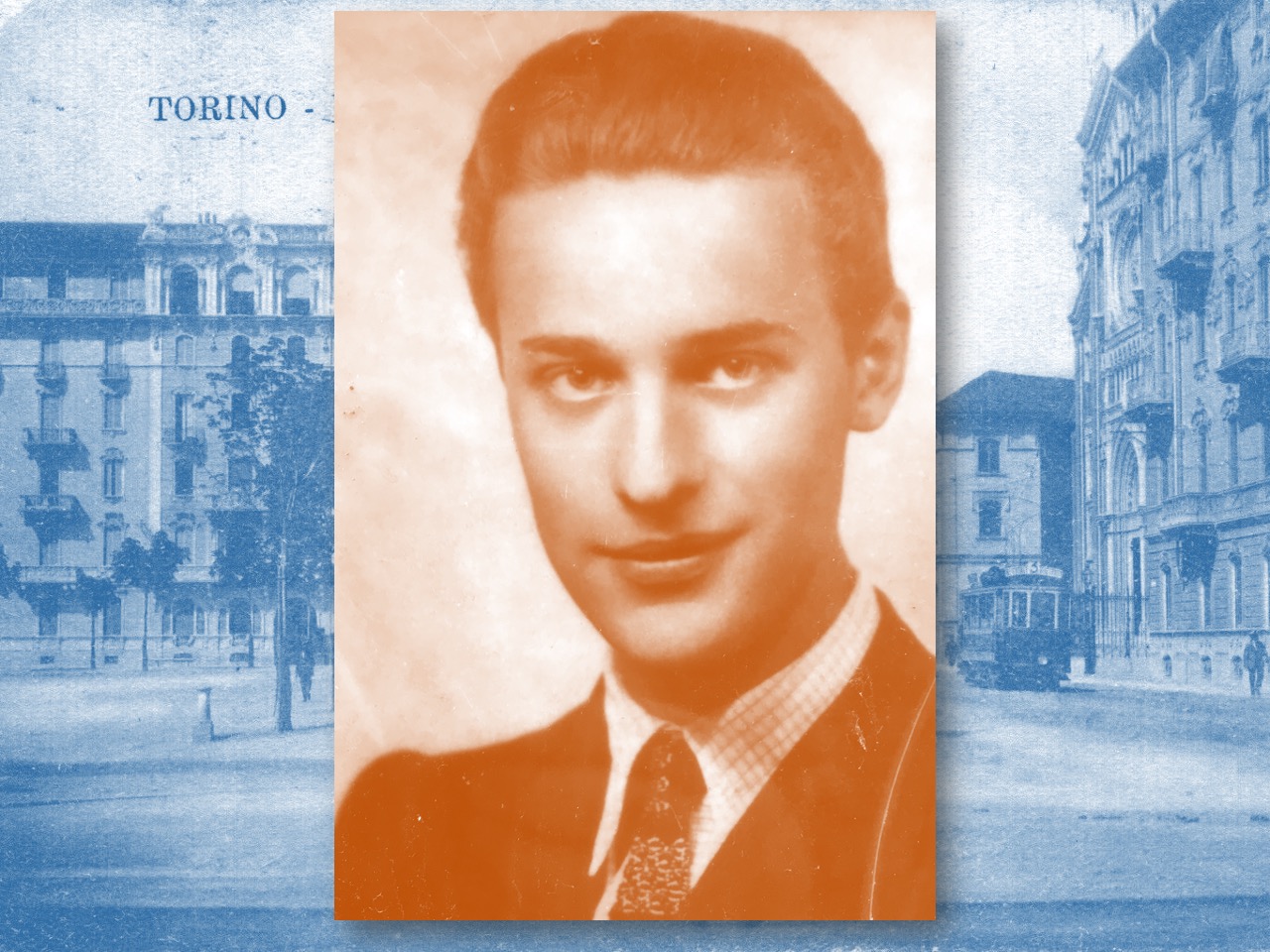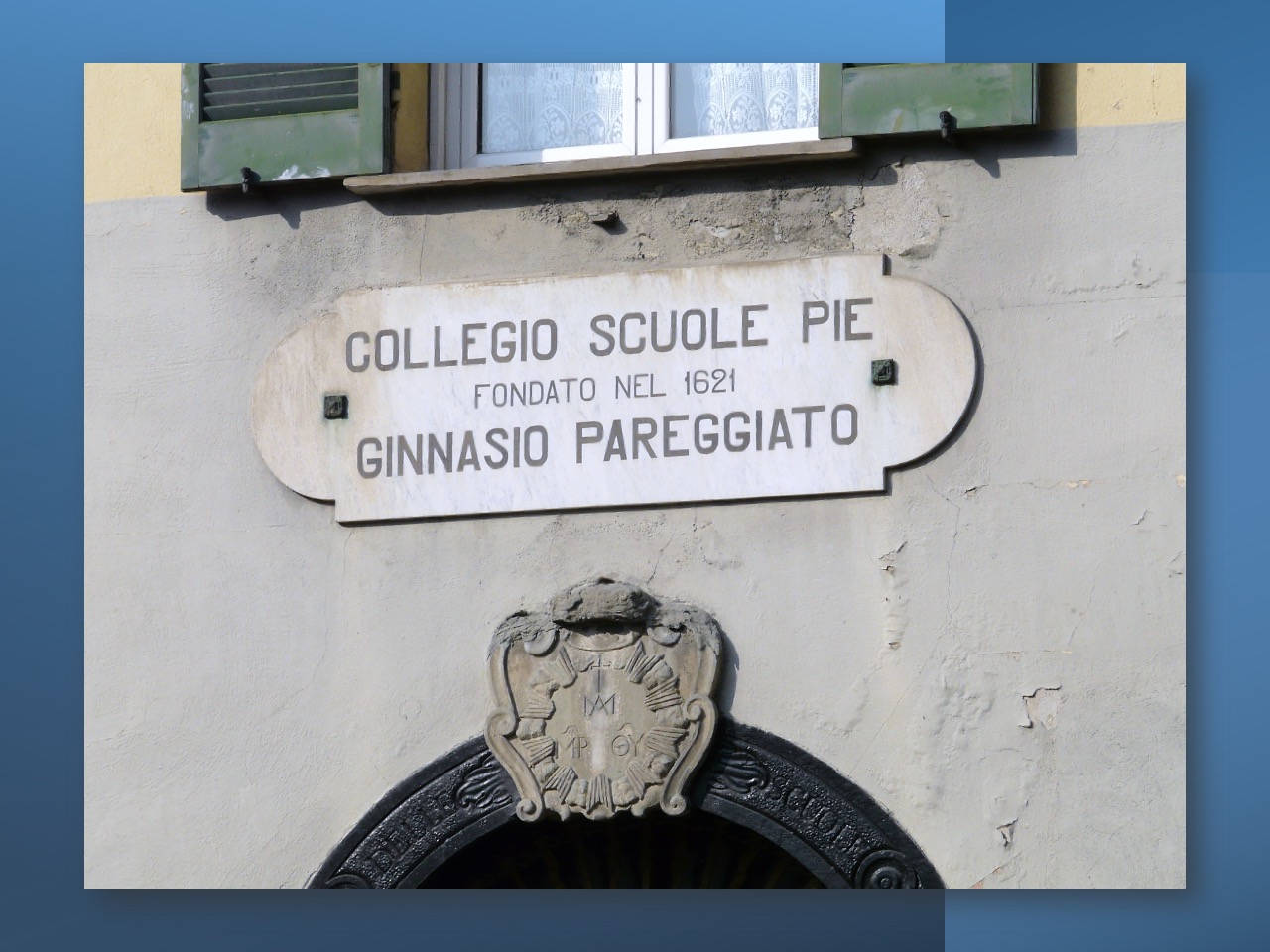Di Katia Bernacci per Civico 20 News
 La bella Torino, città dalle molte sfaccettature, si svela al viaggiatore in prima battuta con le sue costruzioni barocche, legate alle vicende del casato Savoia, da quando, nel 1563, il Duca Emanuele Filiberto decise di installarvi il “quartier generale” che prima si trovava a Chambery. Torino si trovò in questo modo catapultata tra le grandi città europee, perdendo, purtroppo, gran parte delle sue costruzioni romane e medievali, a favore del futuro, dell’ampliamento e della ricostruzione che si erano rese necessarie per la crescita economica della città e anche per ospitare un numero di abitanti decisamente maggiore rispetto al precedente. Quindi parrebbe, al viaggiatore che lanci uno sguardo distratto, che Torino sia solo testimone di quel periodo storico e soprattutto di quell’architettura, che, dal Millecinquecento al Millesettecento, ha visto alternarsi il fior fiore degli architetti e degli artigiani della loro epoca: Ascanio Vitozzi, Carlo di Castellamonte, Guarino Guarini e Filippo Juvarra.
La bella Torino, città dalle molte sfaccettature, si svela al viaggiatore in prima battuta con le sue costruzioni barocche, legate alle vicende del casato Savoia, da quando, nel 1563, il Duca Emanuele Filiberto decise di installarvi il “quartier generale” che prima si trovava a Chambery. Torino si trovò in questo modo catapultata tra le grandi città europee, perdendo, purtroppo, gran parte delle sue costruzioni romane e medievali, a favore del futuro, dell’ampliamento e della ricostruzione che si erano rese necessarie per la crescita economica della città e anche per ospitare un numero di abitanti decisamente maggiore rispetto al precedente. Quindi parrebbe, al viaggiatore che lanci uno sguardo distratto, che Torino sia solo testimone di quel periodo storico e soprattutto di quell’architettura, che, dal Millecinquecento al Millesettecento, ha visto alternarsi il fior fiore degli architetti e degli artigiani della loro epoca: Ascanio Vitozzi, Carlo di Castellamonte, Guarino Guarini e Filippo Juvarra.
Seppur le costruzioni di cui stiamo parlando, il Palazzo Reale, il Castello del Valentino, piazza Carlina, la chiesa di san Lorenzo, per citarne alcune, siano davvero molto belle, il passato, specialmente quello remoto, ha un fascino particolare, che spinge a cercare nuove testimonianze che portino alla luce le radici di un popolo da sempre posto in un luogo di passaggio, fiero ma allo stesso tempo modesto, un po’ distaccato dagli eventi e dagli ansiosi tentativi di crescita delle grandi città nelle vicinanze.
Negli anni le ricerche non sono state infruttuose, anche grazie all’instancabile lavoro del Gruppo Archeologico Torinese, che in quarant’anni di lavoro e ricerca ha portato all’attenzione dei cittadini torinesi molti resti archeologici, creando eventi volti alla divulgazione, con una particolare attenzione alla vita e agli spazi degli uomini e delle donne di quelle epoche per noi remote. Fabrizio Diciotti, del Gruppo Archeologico, autore del libro Archeo Torino, si è occupato non solo della ricostruzione di mappe e disegni che guidano il visitatore, che sia un abitante della città o un turista, tra il dedalo delle vie e i resti romani e medievali, ma delle ricerche sulle ultime scoperte archeologiche che sono state davvero stupefacenti.
Ma vediamo dalle parole di Diciotti che cosa è avvenuto: «Com’è noto, gli isolati del centro storico più antico, il ‘quadrilatero’, sorgono in buona parte sulle insulae di epoca romana, che nei primi secoli dobbiamo immaginarci pressoché completamente edificate, dense di costruzioni. Più tardi, quando Augusta Taurinorum andò trasformandosi in Taurinum, sulle insulae si impostarono isolati medievali più irregolari e meno fittamente costruiti, la cui zona centrale fu spesso utilizzata come area aperta, destinata anche a usi rurali. Quando poi, a partire dall’epoca barocca, gli isolati furono riedificati o comunque rinnovati con nuovi palazzi, mentre il perimetro veniva intaccato da fondamenta e cantine anche a due piani (gli “infernotti”), in genere la parte centrale continuò a restare libera da costruzioni: ciò ha di fatto salvato buona parte della stratigrafia sia romana che medievale, perlomeno nelle aree più interne degli isolati. È grazie a questa caratteristica che gli scavi archeologici degli ultimi anni hanno restituito, finalmente, anche le dimore degli antichi abitanti di Torino, oltre alle strade su cui camminavano e alle tracce delle loro sepolture. Ma non solo: il monitoraggio archeologico ha consentito anche scoperte impreviste in luoghi e aree insospettabili o che si credevano già sufficientemente indagate, sia in città che nei suoi immediati dintorni».
Che dire infatti dei lavori di manutenzione compiuti nei sotterranei della chiesa della Consolata, dai quali sono emerse le rovine della chiesa romanica di Sant’Andrea, di cui un anonimo cronista della Novalesa, parlava già nell’XI secolo, definendola la più bella della città? Oppure del mosaico di Atteone, scoperto durante i lavori di trasformazione dell’ex convento degli Agostiniani – all’angolo tra via delle Orfane e via Santa Chiara – dove, in un complesso residenziale, è stato rinvenuto un complesso di ambienti di epoca romana imperiale, databile tra il I e il III secolo. E poi le incredibili scoperte dell’area dello stabilimento Lavazza, dove nel 2014, per i lavori di ampliamente e costruzione di un parcheggio, venne rinvenuta una stele funeraria del II secolo e a seguire un intero complesso funerario paleocristiano, comprensivo della Basilica di San Secondo, del IV o V secolo, di cui abbiamo notizie nel X secolo.
Scrive la Casartelli Novelli che una basilica extramuranea dedicata a S. Secondo «è documentata come antica nell’anno 916 o 928 e la narrazione della Cronaca della Novalesa precisa che al tempo del vescovo Guglielmo (902-926 ca.), per il timore delle distruzioni saracene, il corpo del martire fu portato dentro le mura della città; in un diploma del 1041 del vescovo Guido (1039-1044) la chiesa di S. Secondo fuori le mura risulta rovinata [...], e un diploma del 1044 dello stesso vescovo concede ad Alberico abate la chiesa di S. Secondo fuori le mura, rovinata dai “pagani”, affinché la restauri e vi istituisca un monastero».
Per quale motivo l’area fu abbandonata, non lo sappiamo, possiamo solo immaginare che le continue incursioni di saraceni e ungari avessero fatto sì che si cercassero luoghi più riparati. La Lavazza è riuscita a creare un sito museale moderno e interessante, che copre 1600 mq di superficie e che si può vedere dalla strada, grazie alle grandi vetrate. Una nota curiosa ci proviene ancora da Diciotti: «su uno dei mattoni usati per realizzare una delle sepolture, di fronte alla chiesa, è stato graffito un orante a braccia aperte, ossia atteggiato nel gesto dell’expansis manibus, iconografia nota nell’ambito paleocristiano; l’emblema, tracciato da un devoto torinese circa quindici secoli fa, è ora diventato il logo dell’area archeologica».
Le nuove scoperte non sono finite certo con questo breve elenco, ma la Torino del passato emerge anche in altri resti, per fare qualche esempio: nel 1873 sono stati trovati due oggetti in pietra levigata in borgata Sassi, presso corso Casale, risalgono al V millennio a.C., è la più antica traccia della presenza umana in città. Il nostro viaggio prevede necessariamente grossolani salti, per questo ci dobbiamo spostare nella Torino dei taurini, popolazione celto-ligure che si era installata probabilmente alla confluenza tra la Dora e il Po, e che hanno lasciato tracce in un’area indagata dal Gruppo Archeologico dal 1991: si tratta di Bric San Vito, nel territorio di Pecetto, dove gli scavi hanno portato alla luce, sotto i livelli medievali e romani, di un sito taurino del IV-III secolo a.C.
Ed eccoci all’epoca romana, la città cresce, forma un perimetro di 700x750 metri, siamo nel 27 d.C., dicono le fonti, l’insediamento è di primaria importanza come luogo di passaggio, in particolare per il valico delle Alpi verso la Francia. Tra le vestigia dell’epoca romana ancora visibili: i resti del Teatro Romano nell’area compresa tra il parco archeologico e via XX Settembre, la Porta Palatina, le mura romane che si trovano in vari punti della città, forse qualcuno ricorda che fino a una ventina di anni fa, in via Garibaldi si trovava un vetro, al di sotto del quale si potevano vedere i resti delle mura di porta Susina, purtroppo è stato coperto con una lastra di cemento. Del Medioevo in città è rimasto poco, ma quel poco è piuttosto interessante: Palazzo Madama, oggi Museo Civico di Arte Antica, sorge su resti romani dove si trovava la porta Decumana, che accoglieva coloro che arrivavano in città dal lato del Po, e divenne fortezza per difendere la città. Anche la chiesa di San Domenico nella via omonima, risale al Medioevo, sorta nel 1227, è stata sede della Santa Inquisizione, e al suo interno si possono trovare affreschi trecenteschi.
Ma non finisce qui, Torino ha una lunga storia alle spalle, e se si passeggia per il centro cittadino, oppure in periferia, si possono ancora trovare alcune cascine ristrutturate che hanno centinaia di anni o resti di castelli, come nel caso del Castello di Lucento, vicino a corso Lombardia, di cui abbiamo notizia dal 1335, diventato sede della Teksid e oggi dell’A.P.I.; insomma, come in un universo parallelo, il passato convive nel nostro presente: basta cercarlo per fare un vero e proprio viaggio nel tempo!
Katia Bernacci
Bibliografia
Archeo Torino, di Fabrizio Diciotti.
Foto di Marino Olivieri.
© 2023 CIVICO20NEWS - riproduzione riservata
Stampa solo il testo dell'articolo Stampa l'articolo con le immagini
Articolo pubblicato il 10/09/2023